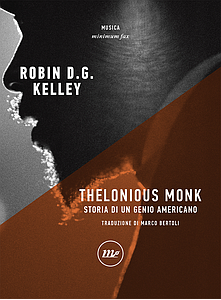Narra la leggenda che nei credit di Trio figuri anche Bill Bruford nonostante non vi abbia suonato, proprio perché Robert Fripp gli riconobbe l'idea di non aver mosso percussione alcuna. Che sia vero o no, è tipicamente da Robert Fripp, e non solo sul piano della mera provocazione tipicamente british.
Fatto sta che passare da questa sorniona visione artistica (del 1974) al tirar fuori ben tre batterie (in questo 2016), ne passa.
A livello emotivo, il concerto di Roma ha smosso il freddo calcolatore che è in me: non nascondo che ascoltando cose come The Letters (una delle mie preferite insieme a Book of Saturday, purtroppo e invece non eseguita) o Epitaph, il mio cuore si è commosso all'inverosimile, solcando qualche lacrimuccia nella guancia ormai cinquantenne.
Però bisogna anche avere il coraggio di astrarsi, di uscire fuori da se stessi: splendidi tecnicismi, impressionanti controtempi su controtempi, ma troppi tom e troppe casse gratuite.
Mia moglie ed io avevamo due posti eccellenti, ma Mel Collins ce lo siamo persi spesso e volentieri... per tacer dei (rari, stranamente) solismi di Fripp, umiliati da fracassoni rullanti.
Per carità: Vroom riletta tipo Peter Gunn Theme ha avuto un suo fascino; Schizoid Man interrotta da un drum solo di quasi dieci minuti, è già diventato un mo(nu)mento di rara eternità; Talking Drum sembrava uscita due giorni fa... però c'è qualcosa che non torna in questa operazione.
Fripp mi ha insegnato - ci ha insegnato - a lavorare per sottrazione. Ricordiamo cose tipo Islands: la Les Paul del nostro idolo quasi non si sente. Ricordiamo The Night Watch: Fripp esegue un solo di rara nitidezza senza "petrucciare" mai. Ogni brano dei King Crimson, insomma, è sempre stato caratterizzato dall'incantevole incontro tra grazia e matematica, tra calcolo e improvvisazione, tra algoritmo e pause. Sottrazione, sottrazione, sottrazione.
Nel concerto di Roma, invece, si è persa totalmente questa attitudine, questo sapore, questa lezione di vita (come l'ha definita anche Bollani, presentando proprio Fripp e Zappa come suoi unici esempi di come ci si debba avvicinare alla composizione).
Qualcuno potrebbe farmi notare come nel dvd Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind che racconta questo Elements Tour non ci siano gli echi della pessima acustica della Conciliazione, e che si possono apprezzare serenamente le tre batterie.
Ma non mi basta, e non posso accettare di dover ragionare con questi distinguo: quelle tre batterie sono diventate troppe. Una scelta artistica che francamente non riesco proprio a comprendere.
È vero, i King Crimson degli anni '90 ne avevano due: ma una era di Bill Bruford, delicato e perfetto come pochi. È vero anche che il Miles Davis elettrico di batteristi ne usò addirittura tre: ma erano misurati e ben calibrati.
Qui abbiamo avuto: Pat Mastellotto, che da sempre picchia troppo e senza fantasia; Gavin Harrison - anche direttore musicale - che ha usato il rullante come la carta sulla lingua; Jeremy Stacey, che notoriamente ha un'eccellente anima jazz, soffocata però dai due comprimari.
Tra le curiosità: girava voce che non avremmo mai ascoltato qualcosa del primo periodo con Adrian Belew. Leggenda vuole infatti, che lui e Fripp abbiano litigato di brutto. E proprio mentre mi stavo rassegnando a subire la censura sul trittico degli anni '80, parte Indiscipline in una mirabile versione "lirica 2.0"... le cui parole, guarda caso, non sono di Adrian, ma della moglie, Margaret.
Una volta, quando Fripp si ritirò temporaneamente dalle scene, scrissi che era finita un'èra. Ma non l'era del prog, cui solo gli ignoranti assimilano i King Crimson; semmai era finita l'èra della musica rispettosa di se stessa.
Sabato sera, i King Crimson hanno rispettato il passato, hanno dimostrato che ha ancora molto da dire, che è "attuale" e originale all'inverosimile... ma hanno dimenticato la musica.
Tornando al me romanticone, invece, questo è stato l'ultimo concerto rock cui ho assistito. Mi piace averlo fatto insieme ai miei amici di sempre.
La scaletta
Tuning Up
Larks’ Tongues in Aspic (Part I)
Pictures of a City
Cirkus
The Letters
Sailor’s Tale
Epitaph
Hell Hounds of Krim
Easy Money
Vroom
Peace: An End
Fairy Dust
Meltdown
The Talking Drum
Larks’ Tongues in Aspic (Part II)
----
Magic Sprinkles
Lizard
Indiscipline
The Court of the Crimson King
Red
The ConstruKction of Light
A Scarcity of Miracles
Radical Action II
Level 5
Starless
----
Devil Dogs of Tessellation Row
21st Century Schizoid Man
Visualizzazione post con etichetta Stefano Bollani. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Stefano Bollani. Mostra tutti i post
14 novembre 2016
The elements of King Crimson tour 2016 - Il concerto di Roma
26 novembre 2013
MONK, la biografia necessaria (minimum fax)
Se il jazz fosse un solido, sarebbe una tavola; non particolarmente complessa, né vistosa. Ci penserebbero i musicisti a darle i toni e i colori appropriati, magari temporanei, sicuramente estemporanei, comunque intrisi di fugaci bellezze anche per l'ascoltatore più esperto.
Miles Davis starebbe fermo al centro. Non si muoverebbe di un millimetro. Per lui la tavola non esiste. I suoi suoni andrebbero solo in alto, arrampicandosi all'infinito.
Quando la gente cammina - o sta ferma - non si guarda mai intorno; Miles Davis, invece, ha sempre avuto la rara genialità di non curarsi dell'ambiente, ma di esplorarne il non visibile, il non immaginabile.
Keith Jarrett penserebbe solo a se stesso: suonerebbe guardando uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio... passerebbe ere e ore alla ricerca del suo io, convinto che sia così incommensurabile da non essere quantificabile se non dal suo pianismo.
Chick Corea correrebbe sopra questa tavola, come un eterno bambino, spensierato e un po' saccente, inseguito da Bollani, a loro volta osservati con sorniona pazienza da Mingus e dai due Evans (Gil e Bill), gli eterni maturi di una genìa di monumenti insormontabili...
La lista è lunga, infinita: ogni musicista jazz avrebbe il suo spazio e il suo modo di interpretarlo.
E poi ci sarebbe Monk.
Dico "sarebbe", perché Monk si metterebbe lì, con incosciente leggerezza, a raccontare gli spigoli. Ogni solido ha uno o più spigoli, anche una sfera se vogliamo. La tavola del jazz ne ha quanti ne volete: ognuno dei quali, però, già sperimentato da Monk.
Anzi, Monk aveva il coraggio di camminare un po' di qua e un po' di là i confini di questa eterna tavola. Sapeva, cioè, che era impossibile raccontare l'oltre di questa tavola: ma era altrettanto consapevole che poteva mettersi di spalle all'ignoto e osservare attentamente ogni singolo spigolo, minuzie di angoli e controangoli, per poi raccontarli a noi avidi ascoltatori tramite un'unica e perfetta capacità di risolvere ogni possibile enigma.
Monk suonava rispettando l'essenza tribale del pianoforte, così ritmico nella sua natura da essere invece usato forzatamente come strumento melodico, forse orchestrale, ma mai nella sua essenza più ancestrale. Il pianoforte ha sempre cercato Monk, e quando poi l'ha trovato si è seduto soddisfatto da una parte, ormai sazio.
Esiste un prima e un dopo 'Round Midnight, ma niente che riesca a sfiorarlo. Esiste un prima e un dopo le musiche di Monk, e poi ci sono solo quelle di Monk; questo libro è la sua storia, questo libro è la biografia di quegli angoli.
Miles Davis starebbe fermo al centro. Non si muoverebbe di un millimetro. Per lui la tavola non esiste. I suoi suoni andrebbero solo in alto, arrampicandosi all'infinito.
Quando la gente cammina - o sta ferma - non si guarda mai intorno; Miles Davis, invece, ha sempre avuto la rara genialità di non curarsi dell'ambiente, ma di esplorarne il non visibile, il non immaginabile.
Keith Jarrett penserebbe solo a se stesso: suonerebbe guardando uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio... passerebbe ere e ore alla ricerca del suo io, convinto che sia così incommensurabile da non essere quantificabile se non dal suo pianismo.
Chick Corea correrebbe sopra questa tavola, come un eterno bambino, spensierato e un po' saccente, inseguito da Bollani, a loro volta osservati con sorniona pazienza da Mingus e dai due Evans (Gil e Bill), gli eterni maturi di una genìa di monumenti insormontabili...
La lista è lunga, infinita: ogni musicista jazz avrebbe il suo spazio e il suo modo di interpretarlo.
E poi ci sarebbe Monk.
Dico "sarebbe", perché Monk si metterebbe lì, con incosciente leggerezza, a raccontare gli spigoli. Ogni solido ha uno o più spigoli, anche una sfera se vogliamo. La tavola del jazz ne ha quanti ne volete: ognuno dei quali, però, già sperimentato da Monk.
Anzi, Monk aveva il coraggio di camminare un po' di qua e un po' di là i confini di questa eterna tavola. Sapeva, cioè, che era impossibile raccontare l'oltre di questa tavola: ma era altrettanto consapevole che poteva mettersi di spalle all'ignoto e osservare attentamente ogni singolo spigolo, minuzie di angoli e controangoli, per poi raccontarli a noi avidi ascoltatori tramite un'unica e perfetta capacità di risolvere ogni possibile enigma.
Monk suonava rispettando l'essenza tribale del pianoforte, così ritmico nella sua natura da essere invece usato forzatamente come strumento melodico, forse orchestrale, ma mai nella sua essenza più ancestrale. Il pianoforte ha sempre cercato Monk, e quando poi l'ha trovato si è seduto soddisfatto da una parte, ormai sazio.
Esiste un prima e un dopo 'Round Midnight, ma niente che riesca a sfiorarlo. Esiste un prima e un dopo le musiche di Monk, e poi ci sono solo quelle di Monk; questo libro è la sua storia, questo libro è la biografia di quegli angoli.
29 gennaio 2013
13 gennaio 2013
l'Italia e il metodo ECM
Conosco l'etichetta ECM dal 1985. A Disco Boom, in via del Tritone, ci si trovava spesso per parlare di musica, acquistare dischi rari e costosi (perlomeno per le nostre tasche), senza sapere che di lì a poco ci sarebbe stata una rivoluzione tecnologica che oggi appare vecchia: l'arrivo dei CD.
E dato che Eicher, il guru dell'etichetta, aveva naso fino, cominciò a dismettere tutti i vecchi supporti del suo catalogo: fu in quell'occasione che acquistai a pochissimo prezzo nastri preziosissimi. Metheny, Jarrett, Surman, Rypdal, Micus, Corea... l'elenco è lunghissimo e ancora oggi fa tremare i polsi.
Per chi ama la musica, innamorarsi della ECM è quasi un passo obbligatorio, nonostante certe attitudini un po' fighette che diventano deliziose appena parte la musica: i famosi cinque secondi di vuoto iniziali, la grafica sobria e sempre all'avanguardia, la scoperta di autori comunque all'altezza delle più rosee aspettative, una implicita ricerca continua, un marketing quasi assente ma non per questo distratto.
E lui sempre presente come produttore, discreto ma totale (indicativa una bella copertina del duo Rava/Bollani, in cui lui s'intravede nella penombra a sinistra, sornione).
Ma c'è un altro elemento caratteristico che ho scoperto solo questi giorni, e che mi ha aperto un mondo di suggestioni: (quasi) tutti i musicisti devo sottostare alla rigida regola del registrare entro due giorni; il terzo è dedicato al missaggio finale.
Ora, immaginatevi la scena, specie per una guest star dell'ultima ora: hai un calendario fitto di concerti e registrazioni, e quindi/anche di impegni mentali non indifferenti, e c'hai incastonato questo salto in Norvegia (e già, si registra lì), sperando magari di passare qualche giorno in profonda contemplazione compositiva. Neanche arrivi con la fiatella dell'affamato, che già devi imparare pezzi altrui o comporre roba tua, poi orchestrare e/o seguire orchestrazioni altrui, creare/accettare un amalgama soprattutto psicologico e spirituale con gli altri, provare, ed eseguire senza tanti errori... in 48 ore! Quarantotto ore!
Ora, è ovvio che uno può aver composto dal tinello di casa propria, e aver provato mesi nel garagetto in fondo al viale, e avere comunque delle belle idee/partiture in mente. Può essere tutto quello che volete, specie tenendo conto che la squadra di musicisti ECM non è fatta di seghe sprovvedute. Ma anche e solo a livello mentale, è un limite terrificante.
È in casi come questo che o hai palle/ovaie e professionalità o te ne stai a casa.
E che c'entra l'Italia citata nel titolo? Niente.
E dato che Eicher, il guru dell'etichetta, aveva naso fino, cominciò a dismettere tutti i vecchi supporti del suo catalogo: fu in quell'occasione che acquistai a pochissimo prezzo nastri preziosissimi. Metheny, Jarrett, Surman, Rypdal, Micus, Corea... l'elenco è lunghissimo e ancora oggi fa tremare i polsi.
Per chi ama la musica, innamorarsi della ECM è quasi un passo obbligatorio, nonostante certe attitudini un po' fighette che diventano deliziose appena parte la musica: i famosi cinque secondi di vuoto iniziali, la grafica sobria e sempre all'avanguardia, la scoperta di autori comunque all'altezza delle più rosee aspettative, una implicita ricerca continua, un marketing quasi assente ma non per questo distratto.
E lui sempre presente come produttore, discreto ma totale (indicativa una bella copertina del duo Rava/Bollani, in cui lui s'intravede nella penombra a sinistra, sornione).
Ma c'è un altro elemento caratteristico che ho scoperto solo questi giorni, e che mi ha aperto un mondo di suggestioni: (quasi) tutti i musicisti devo sottostare alla rigida regola del registrare entro due giorni; il terzo è dedicato al missaggio finale.
Ora, immaginatevi la scena, specie per una guest star dell'ultima ora: hai un calendario fitto di concerti e registrazioni, e quindi/anche di impegni mentali non indifferenti, e c'hai incastonato questo salto in Norvegia (e già, si registra lì), sperando magari di passare qualche giorno in profonda contemplazione compositiva. Neanche arrivi con la fiatella dell'affamato, che già devi imparare pezzi altrui o comporre roba tua, poi orchestrare e/o seguire orchestrazioni altrui, creare/accettare un amalgama soprattutto psicologico e spirituale con gli altri, provare, ed eseguire senza tanti errori... in 48 ore! Quarantotto ore!
Ora, è ovvio che uno può aver composto dal tinello di casa propria, e aver provato mesi nel garagetto in fondo al viale, e avere comunque delle belle idee/partiture in mente. Può essere tutto quello che volete, specie tenendo conto che la squadra di musicisti ECM non è fatta di seghe sprovvedute. Ma anche e solo a livello mentale, è un limite terrificante.
È in casi come questo che o hai palle/ovaie e professionalità o te ne stai a casa.
E che c'entra l'Italia citata nel titolo? Niente.
03 maggio 2012
la bellezza di aver fatto parte del #JazzDay
Devo ringraziare SuperEnzo Pietropaoli se il 30 aprile scorso con mia moglie sono stato tra i 600 spettatori privilegiati che hanno assistito al concerto ufficiale italiano per il primo International Jazz Day organizzato e voluto dall'UNESCO.
Il suo mettermi da parte due preziosissimi biglietti (galleria; fila 5, posti 21 e 23) è stata una perla nella perla. Raramente dimentico questi gesti, che per molti sono piccole cose, ma che per me significano molto.
Io credo nel jazz da quand'ho iniziato ad ascoltare la musica, perché è un genere musicale che suggerisce infinite strade e infiniti linguaggi, tutti affascinanti e dignitosi, e che permette a donne e uomini diversi e di diverse culture di incontrarsi e magari anche di inventare linguaggi nuovi, senza dover rendere conto a chicchessia, senza doversi sforzare di capire il linguaggio dell'altro, perché in quel momento è l'incontro che crea linguaggi, ed esplorazioni, e tante piccole e grandi cose che posso essere descritte con un silenzio, con uno sguardo o con lunghe chiacchierate in compagnia di una buona birra.
Ascoltare Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Jeff Ballard omaggiare e salutare e vivere insieme a noi il jazz, è stata un'esperienza veramente intensa.
Tra i brani eseguiti segnalo Close to you, Barcarolle (Tom Waits sarebbe stato d'accordo), I got rhythm (nella versione più sincopata), Bye bye blackbird (eseguita con rara superbia), Intermezzo dalla "Cavalleria rusticana" (un po' piaciona, ma solo noi italiani sappiamo suonarla in qualsiasi modo), Nero a metà (già, proprio Pino Daniele), e un delicato omaggio a Lucio Dalla con il suo 4-3-1943.
Naturalmente non sono mancati anche i soliti ammiccamenti ai Bitols, su cui - lo sapete - esprimerei sempre e solo riserve (su loro, non su come li hanno suonati i nostri).
Ho una grandissima stima per SuperEnzo perché è un bassista di rara puntualità, accorto e mai molesto, audace ma mai sbruffone, sempre pronto a farsi da parte e sempre attento ai cambi dell'improvvisazione altrui. Quando gli ho detto che lo considero tra i primi dieci bassisti nella storia del jazz, mi ha consigliato di rivolgermi ad uno psichiatra: fatto sta che proprio questa sua prova così celebrativa, consiglierebbe a qualsiasi psichiatra di darmi ragione o cambiare mestiere.
Danilo Rea si è esibito alla grande, limitando certi suoi abbellimenti troppo di mestiere. Certo, il paragone con altri grandi viene spontaneo. L'unico appunto che gli ho sempre fatto è di non fermarsi un attimo per esplorare nuove incognite. Per dirne una: pochi mesi fa, Keith Jarrett ha detto che solo da poco tempo ha iniziato a usare la sua mano sinistra (sic!): per quanto possa sembrare una provocazione, diventa invece una lezione per tutti. Danilo ha rispettato il patto con gli ascoltatori durante questo concerto: però voglio vederlo alla prossima.
Last but not least, tanto di cappello a Ballard: dal suo carnet ho constatato che ha avuto pochissimo tempo per provare con i nostri. Eppure sembrava conoscerli da sempre: disicplinato, puntuale, ironico, attento, preciso, nitido. Mai una sbavatura (persino nel solluccheroso interim di Mascagni).
Insomma, un'esperienza incredibile, che le istituzioni (tutte!) e la Rai hanno ignorato, se non nello speciale web fatto dal sottoscritto (accuratamente attribuito ad altri), e lo speciale di Rai3 trasmesso in seconda serata e sin troppo bollanicentrico. Ma è la solita vecchia storia, no?
Evviva il jazz, però: sempre e comunque.
29 marzo 2011
about a silent way
Dopo qualche mese di decantazione riprendo in mano questo About a Silent Way e mi dò dello scemo: è un revival, ma molto raffinato; c'è una tromba, ma è quella mirabile e pastosa-ma-secca-e-aggressiva-ma-umile di Fabrizio Bosso (ne parlai già qui); c'è un occhialuto che fa dell'elettronica, ma al servizio dell'insieme.
Insomma, e ancora una volta, Musica Jazz mi aveva dato un suggerimento ottimo, e io l'avevo snobbato. La mia tigna è stata più forte dei miei pregiudizi... per fortuna.
Il gruppo:
* martux_m elettronica
* Fabrizio Bosso tromba, flicorno, elettronica
* Francesco Bearzatti sax tenore, clarinetto, elettronica
* Eivind Aarset chitarra, elettronica
* Aldo Vigorito basso
i brani:
1. About A Silent Way
(martux_m, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
2. Hush/Quiet
(martux_m, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
3. Around This Time
(martux_m, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
4. About A Silent Way II
(martux_m, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
Dei quattro, io sento e risento perpetuamente Around this time, perché è una corposa improvvisazione in cui tutti dimostrano d'aver capito cosa esattamente voleva indicare Miles Davis. Ogni musicista dice la sua senza sforare nell'eccesso, l'improvvisazione raggiunge livelli di coinvolgimento quasi carnali, la tecnica e la grazia si accompagnano verso un insieme di suoni e intuizioni che ha dell'incredibile.
Forse sono stato anche condizionato dallo scorso concerto di Bollani che spappolava Zappa, cui ho assistito per affettuosa regalìa della mia signora; e allora la mia indole un po' impigrita si è ridata una scossa (ragazzi, roba che Bollani ha spostato l'Auditorium di qualche metro).
Però sono convinto che questo tipo di follie sonore, tutt'altro che di nicchia (ma forzatamente inserite in essa, perché in Italia usa così), sia necessario per uscire dalla follia musicale grigionissima che stiamo subendo da troppi anni a questa parte.
Costa poco, resta per sempre (anche senza i remix aggiuntivi, che aggiungono pochissimo).
Insomma, e ancora una volta, Musica Jazz mi aveva dato un suggerimento ottimo, e io l'avevo snobbato. La mia tigna è stata più forte dei miei pregiudizi... per fortuna.
Il gruppo:
* martux_m elettronica
* Fabrizio Bosso tromba, flicorno, elettronica
* Francesco Bearzatti sax tenore, clarinetto, elettronica
* Eivind Aarset chitarra, elettronica
* Aldo Vigorito basso
i brani:
1. About A Silent Way
(martux_m, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
2. Hush/Quiet
(martux_m, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
3. Around This Time
(martux_m, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
4. About A Silent Way II
(martux_m, Eivind Aarset, Aldo Vigorito, Dario Colozza)
Dei quattro, io sento e risento perpetuamente Around this time, perché è una corposa improvvisazione in cui tutti dimostrano d'aver capito cosa esattamente voleva indicare Miles Davis. Ogni musicista dice la sua senza sforare nell'eccesso, l'improvvisazione raggiunge livelli di coinvolgimento quasi carnali, la tecnica e la grazia si accompagnano verso un insieme di suoni e intuizioni che ha dell'incredibile.
Forse sono stato anche condizionato dallo scorso concerto di Bollani che spappolava Zappa, cui ho assistito per affettuosa regalìa della mia signora; e allora la mia indole un po' impigrita si è ridata una scossa (ragazzi, roba che Bollani ha spostato l'Auditorium di qualche metro).
Però sono convinto che questo tipo di follie sonore, tutt'altro che di nicchia (ma forzatamente inserite in essa, perché in Italia usa così), sia necessario per uscire dalla follia musicale grigionissima che stiamo subendo da troppi anni a questa parte.
Costa poco, resta per sempre (anche senza i remix aggiuntivi, che aggiungono pochissimo).
Iscriviti a:
Post (Atom)