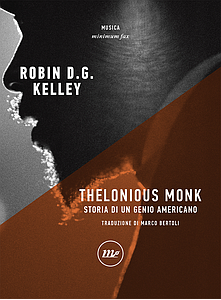Non aspettatevi The Köln Concert o Rio, questo è certo.
Non aspettatevi, cioè, un viaggio sonoro eterogeneo ed empatico: qui siamo di fronte alla sola ratio di Jarrett, dove tutto è squadrato e angolare, dove ogni nota perde la sua dimensione sferica per diventare un bit postmoderno.
Sicuramente è l'ennesimo capolavoro di Jarrett, ma sembra di assistere solo alle sue sinapsi, alle sue nevrosi, alla sua stolida presunzione di essere l'unico e vero dio sceso in Terra (come, del resto, lo è): assistere senza partecipare, assistere senza soffrire, assistere senza gioire.
Il problema è proprio questo: cosa arriva a chi ascolta? Solo la perfezione, ma nulla di più; e a me dopo un po' questa perfezione irrita e insospettisce.
Proposto per festeggiare i 50 anni della ECM - tra le tante registrazioni dal vivo, guarda caso proprio quella da Monaco (la patria dell'etichetta) - questo doppio live conferma il percorso stilistico di Jarrett, sempre più incline all'autoascolto, sempre più litigioso con la rappresentazione, sempre più attento all'estetica.
Sicuramente è spaventoso, è mostruoso, è incredibile che questa summa di assoluto sia frutto di sola improvvisazione, il che ribadisce per la enne-ennesima volta quanto sia bravo questo superuomo; però, alla fine, a me resta nel cuore solo la numero V (il cui incipit ricorda Droned di Phil Collins, pensa tu) e la cover di Answer Me, My Love (sublime).
A volte anche gli dei dovrebbero scendere tra i comuni mortali per comunicare loro la lieta novella: qui, invece, il pubblico viene ignorato, il pulsare del cuore viene frizzato, la morbida pasta dell'anima diventa roccia dura e marmorea, le luci del tramonto si trasformano in neon.
Acquistatelo se siete collezionisti, maniaci del freddo o manager disamorati, altrimenti rimettete sul piatto Radiance o The Melody At Night, With You.
Visualizzazione post con etichetta Keith Jarrett. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Keith Jarrett. Mostra tutti i post
22 novembre 2019
29 marzo 2017
la tetra tetralogia di Keith Jarrett
Registrato nel 1996, questo A Multitude Of Angels è la testimonianza delle ultime improvvisazioni pianistiche lunghe di Keith Jarrett, perlomeno sul piano autobiografico. È per primo Jarrett, infatti, a precisare che considera questi quattro concerti italiani come l'ideale termine delle sue anabasi per piano e cervello.
E già: piano e cervello.
Il pregio di Keith Jarrett è sempre stato anche il suo difetto: suona per se stesso.
Non pretendo che ammicchi verso il pubblico - proprio lui, poi!, o che si esibisca in qualcosa di dissimulatamente commerciale; pretendo, però, che si renda conto che sperimentare e improvvisare siano due ambiti diversi, che possono - e devono - incontrarsi, ma che devono anche sapere quando uno dovrebbe cedere totalmente il posto all'altro, ponendo la parola fine ben prima di annientare l'ultimo degli ascoltatori più fedeli.
Insomma, ogni tanto, caro Jarrett potresti suonare almeno per la musica, magari senza avere il cuore cementificato da pulviscoli cerebrali? Del resto, se in inglese si usa dire giocare la musica, ci sarà pure un motivo.
La ipercelebrazione di questi quattro cd, insomma, risente molto dello sdoganamento in automatico che qualsiasi cosa faccia Jarrett sia buona.
Non siamo di fronte al free jazz più esasperante, come nemmeno ai Concerti di Colonia o Paris Concert o Vienna; ma neanche possiamo parlare di capolavori miliari o di opere di riferimento assolute.
Questa è una collezione per jarrettiani indomiti, molto indomiti, con pochi e radi momenti sublimi. Anzi, in alcuni momenti si ha l'impressione di essere di fronte a un Jarrett che voglia volutamente scimmiottare se stesso (Modena) o buttarla in caciara (Ferrara).
Una parte di me soffre a scrivere così duramente, perché già sa che alla fine amerò pure questa tetralogia, magari dopo il centesimo ascolto. Però tenetevi strette queste considerazioni, prima di spendere quasi 40 euro!
E già: piano e cervello.
Il pregio di Keith Jarrett è sempre stato anche il suo difetto: suona per se stesso.
Non pretendo che ammicchi verso il pubblico - proprio lui, poi!, o che si esibisca in qualcosa di dissimulatamente commerciale; pretendo, però, che si renda conto che sperimentare e improvvisare siano due ambiti diversi, che possono - e devono - incontrarsi, ma che devono anche sapere quando uno dovrebbe cedere totalmente il posto all'altro, ponendo la parola fine ben prima di annientare l'ultimo degli ascoltatori più fedeli.
Insomma, ogni tanto, caro Jarrett potresti suonare almeno per la musica, magari senza avere il cuore cementificato da pulviscoli cerebrali? Del resto, se in inglese si usa dire giocare la musica, ci sarà pure un motivo.
La ipercelebrazione di questi quattro cd, insomma, risente molto dello sdoganamento in automatico che qualsiasi cosa faccia Jarrett sia buona.
Non siamo di fronte al free jazz più esasperante, come nemmeno ai Concerti di Colonia o Paris Concert o Vienna; ma neanche possiamo parlare di capolavori miliari o di opere di riferimento assolute.
Questa è una collezione per jarrettiani indomiti, molto indomiti, con pochi e radi momenti sublimi. Anzi, in alcuni momenti si ha l'impressione di essere di fronte a un Jarrett che voglia volutamente scimmiottare se stesso (Modena) o buttarla in caciara (Ferrara).
Una parte di me soffre a scrivere così duramente, perché già sa che alla fine amerò pure questa tetralogia, magari dopo il centesimo ascolto. Però tenetevi strette queste considerazioni, prima di spendere quasi 40 euro!
12 luglio 2015
la Creazione di Keith Jarrett
Ecco, il quinto brano di Creation sembra muoversi così.
Del resto, spesso Jarrett sembra donare all'ascoltatore la parte finale di un discorso più ampio, che ha tenuto dentro di sé quasi controvoglia, e altrettanto controvoglia ha deciso di concluderne solo una minima parte ad alta voce.
Creation celebra i 70 anni di un Jarrett quasi in sordina, quasi fossero più intriganti le pause tra un brano e l'altro.
Eppure, è un grande disco.
Cercare di paragonarlo alla "pietra angolare" di Colonia è quasi fastidioso. Magari è più vicino a Radiation, anche se meno organico, o a Rio, anche se è meno strutturato.
Però Creation è un capolavoro. E dovete cominciarlo dal brano numero V.
Poi vi fermate. Spegnete lo stereo. E incominciate l'ascolto completo solo da domani, meglio dopodomani.
29 aprile 2015
gli eroi di iiro rantala
Parliamo di pianisti: ne conosco così tanti che trovo perlomeno ingiusto stilare una classifica. Se, però, insistete, possiamo pensare che il mondo del pianoforte jazz sia un po' come una piramide, la cui punta è Keith Jarrett e tutto il resto scende giù... Allevi? Nessun problema: non è un pianista.
Ebbene, dove andrebbe collocato Rantala? Eh, è una bella domanda. Perché se dovessimo basarci solo sul singolo ascolto di questo Lost Heroes ci verrebbe istintivo collocarlo vicino all'entrata dei visitatori di questa ipotetica piramide.
Certo, alcuni brani sono comunque - e chiaramente - complessi o tendenti al complesso: però, poi, è chiaro che Rantala tenti più di comunicare qualcosa direttamente e senza fronzoli, piuttosto che restare pervicacemente rinchiuso in se stesso, costringendo l'ascoltatore ad entrare chissà in quale antro mistico. Del resto, nell'intervista che trovate alla fine di questo post, il nostro amico dichiara esplicitamente questa attitudine.
Il cd è un evidente omaggio ai compositori (o amici) più amati da Rantala. Molti sono noti: Bill Evans (il pianista, ovviamente), Toots Thielemans, Michel Petrucciani, Jaco Pastorius, Errol Garner, Art Tatum, Oscar Peterson. Un paio sono "classici": Sibelius e Pavarotti; un altro paio di nicchia: Pekka Pohjola e Esbjörn Svensson.
L'etichetta che lo rappresenta ne decanta la misura e l'eleganza: e in effetti sono due pregi che si sentono e si vivono con dolce intensità; soprattutto colpisce l'esattezza delle note, che è un'attitudine che a me piace moltissimo.
Ebbene, non sono riuscito ad appassionarmi totalmente a questo lavoro, finché non ho incrociato il secondo video che trovate qui sotto: è l'elegia dedicata a(l mio amatissimo bassista) Pekka Pohjola, riproposta dal vivo con l'intrigante chitarra di Marzi Nyman e... il beatbox di Felix Zenger. Surreale quanto eccezionale.
25 gennaio 2015
Hamburg '72, un brutto cd di jazz
Insomma, è un po' come quando Fonzie doveva dire "ho sbagliato" ma non ci riusciva. Eppure, fatemelo dire prima che ci ripensi: questo Hamburg '72 è brutto forte.
Pretenzioso, serioso, allusivo, senza alcun afflato innovativo, vecchio nell'anima e anziano nell'ascolto, è un'opera senza capo né coda che ammicca al futuro senza entusiasmo e coraggio.
Un'opera, insomma, che se fosse uscita dalla penna di un qualsiasi altro musicista sarebbe stata stroncata di netto come solo meritano opere così pretenziose.
Keith Jarrett strimpella il piano, sofficchia sul sax soprano e sul flauto, prendendosi la libertà di contribuire ad alcune (inutili) percussioni. L'ombra di Charlie Haden smanazza il contrabbasso quel tanto che basta. Paul Motian riesce ad essere più "motian" del solito, senza cioè dare un senso a un batterismo già di suo poco felice (conosco la discografia migliore del tipo, e non mi ha mai detto un granché; lo preferisco come session man silente).
Si sentono chiaramente la devozione e i rimandi a Ornette Coleman, ma nella sua parte strutturale e non artistica. Voglio dire che non si buttano note in caotica caciara se non c'è anima; altrimenti, è tutto molto pungente e noioso.
Qua e là sguscia via il Bill Evans più sperimentale. Ma sono fuochi fatui di un Jarrett decisamente fuori registro.
E dire che le ultime finestre dal passato remoto di Jarrett mi erano piaciute, sia da solo che in trio: ma qui mi sono sentito preso in giro, quasi mortificato, specie perché la critica lo ha incensato senza difficoltà alcuna. Forse ci vorrebbe un po' più di coraggio e di onestà intellettuale: se un'opera è brutta, tanto vale dirlo. E questa è un'opera da non comprare.
26 novembre 2013
MONK, la biografia necessaria (minimum fax)
Se il jazz fosse un solido, sarebbe una tavola; non particolarmente complessa, né vistosa. Ci penserebbero i musicisti a darle i toni e i colori appropriati, magari temporanei, sicuramente estemporanei, comunque intrisi di fugaci bellezze anche per l'ascoltatore più esperto.
Miles Davis starebbe fermo al centro. Non si muoverebbe di un millimetro. Per lui la tavola non esiste. I suoi suoni andrebbero solo in alto, arrampicandosi all'infinito.
Quando la gente cammina - o sta ferma - non si guarda mai intorno; Miles Davis, invece, ha sempre avuto la rara genialità di non curarsi dell'ambiente, ma di esplorarne il non visibile, il non immaginabile.
Keith Jarrett penserebbe solo a se stesso: suonerebbe guardando uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio... passerebbe ere e ore alla ricerca del suo io, convinto che sia così incommensurabile da non essere quantificabile se non dal suo pianismo.
Chick Corea correrebbe sopra questa tavola, come un eterno bambino, spensierato e un po' saccente, inseguito da Bollani, a loro volta osservati con sorniona pazienza da Mingus e dai due Evans (Gil e Bill), gli eterni maturi di una genìa di monumenti insormontabili...
La lista è lunga, infinita: ogni musicista jazz avrebbe il suo spazio e il suo modo di interpretarlo.
E poi ci sarebbe Monk.
Dico "sarebbe", perché Monk si metterebbe lì, con incosciente leggerezza, a raccontare gli spigoli. Ogni solido ha uno o più spigoli, anche una sfera se vogliamo. La tavola del jazz ne ha quanti ne volete: ognuno dei quali, però, già sperimentato da Monk.
Anzi, Monk aveva il coraggio di camminare un po' di qua e un po' di là i confini di questa eterna tavola. Sapeva, cioè, che era impossibile raccontare l'oltre di questa tavola: ma era altrettanto consapevole che poteva mettersi di spalle all'ignoto e osservare attentamente ogni singolo spigolo, minuzie di angoli e controangoli, per poi raccontarli a noi avidi ascoltatori tramite un'unica e perfetta capacità di risolvere ogni possibile enigma.
Monk suonava rispettando l'essenza tribale del pianoforte, così ritmico nella sua natura da essere invece usato forzatamente come strumento melodico, forse orchestrale, ma mai nella sua essenza più ancestrale. Il pianoforte ha sempre cercato Monk, e quando poi l'ha trovato si è seduto soddisfatto da una parte, ormai sazio.
Esiste un prima e un dopo 'Round Midnight, ma niente che riesca a sfiorarlo. Esiste un prima e un dopo le musiche di Monk, e poi ci sono solo quelle di Monk; questo libro è la sua storia, questo libro è la biografia di quegli angoli.
Miles Davis starebbe fermo al centro. Non si muoverebbe di un millimetro. Per lui la tavola non esiste. I suoi suoni andrebbero solo in alto, arrampicandosi all'infinito.
Quando la gente cammina - o sta ferma - non si guarda mai intorno; Miles Davis, invece, ha sempre avuto la rara genialità di non curarsi dell'ambiente, ma di esplorarne il non visibile, il non immaginabile.
Keith Jarrett penserebbe solo a se stesso: suonerebbe guardando uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio che riflette uno specchio... passerebbe ere e ore alla ricerca del suo io, convinto che sia così incommensurabile da non essere quantificabile se non dal suo pianismo.
Chick Corea correrebbe sopra questa tavola, come un eterno bambino, spensierato e un po' saccente, inseguito da Bollani, a loro volta osservati con sorniona pazienza da Mingus e dai due Evans (Gil e Bill), gli eterni maturi di una genìa di monumenti insormontabili...
La lista è lunga, infinita: ogni musicista jazz avrebbe il suo spazio e il suo modo di interpretarlo.
E poi ci sarebbe Monk.
Dico "sarebbe", perché Monk si metterebbe lì, con incosciente leggerezza, a raccontare gli spigoli. Ogni solido ha uno o più spigoli, anche una sfera se vogliamo. La tavola del jazz ne ha quanti ne volete: ognuno dei quali, però, già sperimentato da Monk.
Anzi, Monk aveva il coraggio di camminare un po' di qua e un po' di là i confini di questa eterna tavola. Sapeva, cioè, che era impossibile raccontare l'oltre di questa tavola: ma era altrettanto consapevole che poteva mettersi di spalle all'ignoto e osservare attentamente ogni singolo spigolo, minuzie di angoli e controangoli, per poi raccontarli a noi avidi ascoltatori tramite un'unica e perfetta capacità di risolvere ogni possibile enigma.
Monk suonava rispettando l'essenza tribale del pianoforte, così ritmico nella sua natura da essere invece usato forzatamente come strumento melodico, forse orchestrale, ma mai nella sua essenza più ancestrale. Il pianoforte ha sempre cercato Monk, e quando poi l'ha trovato si è seduto soddisfatto da una parte, ormai sazio.
Esiste un prima e un dopo 'Round Midnight, ma niente che riesca a sfiorarlo. Esiste un prima e un dopo le musiche di Monk, e poi ci sono solo quelle di Monk; questo libro è la sua storia, questo libro è la biografia di quegli angoli.
30 dicembre 2012
#UmbriaJazz Jonathan Batiste, una meraviglia tra noi
Concerto memorabile, questo di Jonathan Batiste, di quelli che porti nel cuore e racconterai ai nipoti con languore e nostalgia.
Piano moderno e tradizionale, avventuroso ma mai esagerato, coinvolgente ma mai ammiccante. E poi un uso affettuoso del clavinet per far partecipare anche il pubblico quel tanto che basta.
Apre con un classico di Chopin cui lega avventurosamente una centellinata "Blackbird" dei Beatles. Ancora non canta.
Dopodiché arriva un classico di Morton, roboante ma spolverato di quegli inutili e cinematografici mississippismi.
Poi, silenzio. C'è "Summertime", nella versione più bella che abbia mai sentito in vita mia. Roba da brividi, veramente da brividi. Con un momento solista dodecafonico (!), e gli schiavi che aleggiano tra il pubblico, testimoni sorridenti di torti mai emendati.
E la voce? Perfetta.
Dopo altri maestrismi veramente di qualità, arriva una "St. James Infirmary" che non dà scampo, ricca di riferimenti antichi e moderni che si intrecciano.
Grande spolvero, poi, di "God Bless The Child" con un solista ai limiti dell'inverosimile: mano sinistra che cita Liszt, la destra che esegue Chopin/Beethoven, una cadenza alla Varese, e - udite - un fraseggio che rimanda a Cab Calloway.
Insomma, Batiste è il faro dell'oltre Jarrett. Per fortuna meno autoreferenziale, ma proprio per questo da frequentare.
Piano moderno e tradizionale, avventuroso ma mai esagerato, coinvolgente ma mai ammiccante. E poi un uso affettuoso del clavinet per far partecipare anche il pubblico quel tanto che basta.
Apre con un classico di Chopin cui lega avventurosamente una centellinata "Blackbird" dei Beatles. Ancora non canta.
Dopodiché arriva un classico di Morton, roboante ma spolverato di quegli inutili e cinematografici mississippismi.
Poi, silenzio. C'è "Summertime", nella versione più bella che abbia mai sentito in vita mia. Roba da brividi, veramente da brividi. Con un momento solista dodecafonico (!), e gli schiavi che aleggiano tra il pubblico, testimoni sorridenti di torti mai emendati.
E la voce? Perfetta.
Dopo altri maestrismi veramente di qualità, arriva una "St. James Infirmary" che non dà scampo, ricca di riferimenti antichi e moderni che si intrecciano.
Grande spolvero, poi, di "God Bless The Child" con un solista ai limiti dell'inverosimile: mano sinistra che cita Liszt, la destra che esegue Chopin/Beethoven, una cadenza alla Varese, e - udite - un fraseggio che rimanda a Cab Calloway.
Insomma, Batiste è il faro dell'oltre Jarrett. Per fortuna meno autoreferenziale, ma proprio per questo da frequentare.
03 maggio 2012
la bellezza di aver fatto parte del #JazzDay
Devo ringraziare SuperEnzo Pietropaoli se il 30 aprile scorso con mia moglie sono stato tra i 600 spettatori privilegiati che hanno assistito al concerto ufficiale italiano per il primo International Jazz Day organizzato e voluto dall'UNESCO.
Il suo mettermi da parte due preziosissimi biglietti (galleria; fila 5, posti 21 e 23) è stata una perla nella perla. Raramente dimentico questi gesti, che per molti sono piccole cose, ma che per me significano molto.
Io credo nel jazz da quand'ho iniziato ad ascoltare la musica, perché è un genere musicale che suggerisce infinite strade e infiniti linguaggi, tutti affascinanti e dignitosi, e che permette a donne e uomini diversi e di diverse culture di incontrarsi e magari anche di inventare linguaggi nuovi, senza dover rendere conto a chicchessia, senza doversi sforzare di capire il linguaggio dell'altro, perché in quel momento è l'incontro che crea linguaggi, ed esplorazioni, e tante piccole e grandi cose che posso essere descritte con un silenzio, con uno sguardo o con lunghe chiacchierate in compagnia di una buona birra.
Ascoltare Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Jeff Ballard omaggiare e salutare e vivere insieme a noi il jazz, è stata un'esperienza veramente intensa.
Tra i brani eseguiti segnalo Close to you, Barcarolle (Tom Waits sarebbe stato d'accordo), I got rhythm (nella versione più sincopata), Bye bye blackbird (eseguita con rara superbia), Intermezzo dalla "Cavalleria rusticana" (un po' piaciona, ma solo noi italiani sappiamo suonarla in qualsiasi modo), Nero a metà (già, proprio Pino Daniele), e un delicato omaggio a Lucio Dalla con il suo 4-3-1943.
Naturalmente non sono mancati anche i soliti ammiccamenti ai Bitols, su cui - lo sapete - esprimerei sempre e solo riserve (su loro, non su come li hanno suonati i nostri).
Ho una grandissima stima per SuperEnzo perché è un bassista di rara puntualità, accorto e mai molesto, audace ma mai sbruffone, sempre pronto a farsi da parte e sempre attento ai cambi dell'improvvisazione altrui. Quando gli ho detto che lo considero tra i primi dieci bassisti nella storia del jazz, mi ha consigliato di rivolgermi ad uno psichiatra: fatto sta che proprio questa sua prova così celebrativa, consiglierebbe a qualsiasi psichiatra di darmi ragione o cambiare mestiere.
Danilo Rea si è esibito alla grande, limitando certi suoi abbellimenti troppo di mestiere. Certo, il paragone con altri grandi viene spontaneo. L'unico appunto che gli ho sempre fatto è di non fermarsi un attimo per esplorare nuove incognite. Per dirne una: pochi mesi fa, Keith Jarrett ha detto che solo da poco tempo ha iniziato a usare la sua mano sinistra (sic!): per quanto possa sembrare una provocazione, diventa invece una lezione per tutti. Danilo ha rispettato il patto con gli ascoltatori durante questo concerto: però voglio vederlo alla prossima.
Last but not least, tanto di cappello a Ballard: dal suo carnet ho constatato che ha avuto pochissimo tempo per provare con i nostri. Eppure sembrava conoscerli da sempre: disicplinato, puntuale, ironico, attento, preciso, nitido. Mai una sbavatura (persino nel solluccheroso interim di Mascagni).
Insomma, un'esperienza incredibile, che le istituzioni (tutte!) e la Rai hanno ignorato, se non nello speciale web fatto dal sottoscritto (accuratamente attribuito ad altri), e lo speciale di Rai3 trasmesso in seconda serata e sin troppo bollanicentrico. Ma è la solita vecchia storia, no?
Evviva il jazz, però: sempre e comunque.
03 febbraio 2012
Danny Grissett, il pianista elegante
In uno degli ultimi numeri avevo letto la recensione di Stride del pianista Danny Grissett (con Vicente Archer al basso e Marcus Gilmore alla batteria): un cd eccellente, sotto ogni punto di vista.
Onestamente, non avevo mai sentito parlare di Grissett prima di quest'opera (la terza del terzetto), e a un primo ascolto ero rimasto scettico. In fondo, si sa, ci sono due tipi di jazzisti: quelli che la musica la servono (tipo Fresu, per intenderci), e quelli che si servono della musica (tipo Jarrett).
Poi, però, ci sono quelli alla John Lewis, che la musica la rispettano, a volte esplorandola, a volte inventandola. Sono i meno vistosi, e quindi da assaggiare lentamente. Grissett è tra questi: e il mio fare un cenno a John Lewis ci sta tutto (cfr il video qui sotto, dove ci sta molto MJQ e nulla di Jacques Loussier... per fortuna).
Va detto che trovo la qualità della registrazione poco dinamica, e che forse un missaggio più accorto avrebbe restituito tutte le eccellenti qualità del trio. Però la forza e la potenza di questo raffinato combo ci sono tutte, e vanno assaporate con attenzione.
Ogni nota raccontata dalla mano destra ha la sua esattezza e ineludibilità. La mano sinistra - apparentemente sorniona - lavora, invece, con armonie moderne e contrappunti amabilmente retro. Gli spart e i rispettivi solisti sembrano proposti da una sola mente, tanto si rispettano e contemporanemante si sfidano con la giusta destrezza. Un approccio generale e condiviso fino all'ultima nota che sottolinea implicitamente una severa attenzione per i particolari. Infine, un paio di brani (Stride e Close Quarters) che potrebbero tranquillamente diventare degli standard.
Insomma, un cd che non dovrebbe mancare nella vostra discoteca.
30 marzo 2011
John Abercrombie
John Abercrombie è uno dei chitarristi più complessi con cui abbia mai avuto a che fare. Facendo un parallelo forzatissimo, mi ricorda quello che molti critici competenti attribuiscono a un altro vate della chitarra, però più vicino al rock e allo sperimentale: Robert Fripp. Per carità, nessuna comunanza stilistica. Però: così come Fripp non attinge a nessuna tradizione blues per esprimere le sue complesse tessiture (apparentemete, però, nitide e liquide), Abercrombie sembra voler andare oltre il chitarrismo jazz per spostare la sua improvvisazione in un contesto così ibrido e rischioso, che a volte è necessaria una pausa di qualche minuto per passare poi all'ascolto del brano successivo.
Attenzione: non è "difficile"; anche perché non esiste musica "difficile", semmai è l'ascoltatore che manca di coraggio. Insomma, Abercrombie si fa ascoltare, ti prende per mano, vuole dirti qualcosa e ti costringe abilmente e amabilmente a seguirlo passo dopo passo. Ogni sua nota, cioè, ha una storia, una (e)voluta volontà di esplorare e raccontare, di sfidare e rispettare, di andare oltre aspettando però che l'ascoltatore si adatti a quel rischio.
I chitarristi più noti, spesso usano alcuni passaggi della propria improvvisazione, più per appoggiarsi a qualcosa di fidato, che per continuare a camminare nel sentiero vastissimo dell'improvvisazione stessa. Mi vengono in mente John Scofield, Mike Stern e anche il primissimo Santana: bravi, bravissimi; ma spesso dedicati al conosciuto per cercare poi l'ignoto, anziché lasciarsi andare immediatamente al rischio.
Abercrombie, invece, sembra sempre proporre note esatte ma inaspettate.
Invece di rompervi ancora, vi consiglio alcuni cd di partenza, cosicché possiate poi farvi un'idea di massima della potenza di questo piccolo genio della chitarra.
Timeless, che ha come tastierista Jan Hammer (ex Mahavishnu, poi convertitosi a Miami Vice), e il jarrettiano Jack DeJohnette alla batteria. Un'opera esplosiva, veramente di classe, che nonostante l'età (1974), propone ancora oggi suggerimenti insospettabili, mantenendo quella gioventù suggerita anche dal titolo.
I vari Gateway, progetti musicali condivisi con Dave Holland (il bassista per eccellenza) e sempre con DeJohnette. Roba più complicata, forse, ma dove Abercrombie dà ampia prova di saper guidare e lasciarsi guidare con inusitata umiltà.
Getting There, album che sembra aprire alla fusion commerciale, ma solo nel primo brano, e che vede Marc Johnson al basso, Peter Erskine alla batteria, e tre cameo del compianto tenorsassofonista Michael Brecker. Album delizioso, forse troppo, ma utile a chi volesse sfidare la proprie conoscenze.
Eventyr, dove il sax soprano di Jan Garbarek e la chitarra di Abercrombie ben si amalgamano, scivolando sul ghiaccio; aiutati anche dal metheniano Nana Vasconcelos, che usa ogni percussione gli venga a tiro.
Abercrombie si ripete con Erskine e Johnson in almeno due opere necessarie: Current Events (con in apertura un simpatico omaggio a Clint Eastwood), e il live a loro nome.
Aggiungo i miei preferiti, ma forse troppo in là (per cui è meglio prima ripassare quelli già segnalati): Animato (con Jon Christiensen alla batteria e Vince Mendoza alle tastiere); il solista Characters (sperimentazione jazz veramente di classe); Sargasso Sea (insieme al collega - folle come pochi - Ralph Towner); Open Land, brividi assicurati con Mark Feldman al violino, Kenny Wheeler alla tromba, Joe Lovano al sax tenore, Dan Wall all'organo e Adam Nussbaum alla batteria.
Con questi ultimi due (Wall e Nussbaum), Abercrombie ha tirato giù una serie di opere veramente interessante. Se, però, amate poco l'organo, lasciate perdere; altrimenti, invece, comprateli tutti, qualsiasi titolo va bene.
Attenzione: non è "difficile"; anche perché non esiste musica "difficile", semmai è l'ascoltatore che manca di coraggio. Insomma, Abercrombie si fa ascoltare, ti prende per mano, vuole dirti qualcosa e ti costringe abilmente e amabilmente a seguirlo passo dopo passo. Ogni sua nota, cioè, ha una storia, una (e)voluta volontà di esplorare e raccontare, di sfidare e rispettare, di andare oltre aspettando però che l'ascoltatore si adatti a quel rischio.
I chitarristi più noti, spesso usano alcuni passaggi della propria improvvisazione, più per appoggiarsi a qualcosa di fidato, che per continuare a camminare nel sentiero vastissimo dell'improvvisazione stessa. Mi vengono in mente John Scofield, Mike Stern e anche il primissimo Santana: bravi, bravissimi; ma spesso dedicati al conosciuto per cercare poi l'ignoto, anziché lasciarsi andare immediatamente al rischio.
Abercrombie, invece, sembra sempre proporre note esatte ma inaspettate.
Invece di rompervi ancora, vi consiglio alcuni cd di partenza, cosicché possiate poi farvi un'idea di massima della potenza di questo piccolo genio della chitarra.
Timeless, che ha come tastierista Jan Hammer (ex Mahavishnu, poi convertitosi a Miami Vice), e il jarrettiano Jack DeJohnette alla batteria. Un'opera esplosiva, veramente di classe, che nonostante l'età (1974), propone ancora oggi suggerimenti insospettabili, mantenendo quella gioventù suggerita anche dal titolo.
Getting There, album che sembra aprire alla fusion commerciale, ma solo nel primo brano, e che vede Marc Johnson al basso, Peter Erskine alla batteria, e tre cameo del compianto tenorsassofonista Michael Brecker. Album delizioso, forse troppo, ma utile a chi volesse sfidare la proprie conoscenze.
Eventyr, dove il sax soprano di Jan Garbarek e la chitarra di Abercrombie ben si amalgamano, scivolando sul ghiaccio; aiutati anche dal metheniano Nana Vasconcelos, che usa ogni percussione gli venga a tiro.
Abercrombie si ripete con Erskine e Johnson in almeno due opere necessarie: Current Events (con in apertura un simpatico omaggio a Clint Eastwood), e il live a loro nome.
Aggiungo i miei preferiti, ma forse troppo in là (per cui è meglio prima ripassare quelli già segnalati): Animato (con Jon Christiensen alla batteria e Vince Mendoza alle tastiere); il solista Characters (sperimentazione jazz veramente di classe); Sargasso Sea (insieme al collega - folle come pochi - Ralph Towner); Open Land, brividi assicurati con Mark Feldman al violino, Kenny Wheeler alla tromba, Joe Lovano al sax tenore, Dan Wall all'organo e Adam Nussbaum alla batteria.
Con questi ultimi due (Wall e Nussbaum), Abercrombie ha tirato giù una serie di opere veramente interessante. Se, però, amate poco l'organo, lasciate perdere; altrimenti, invece, comprateli tutti, qualsiasi titolo va bene.
07 aprile 2010
highway rider
Motivato da numerose critiche positive mi sono avventurato dentro Highway Rider, nuova fatica jazz classicheggiante di Brad Mehldau. Bella, molto bella davvero. Ricca di spunti, idee, riflessioni, lunghe vie che ti portano altrove... ma in maniera troppo rassicurante.
 Avevo già sperimentato questa sua attitudine in The Art of the Trio, Vol. 3: Songs, consigliatami da un folle quanto ottimo commesso del Ricordi di via Orlando, qui a Roma: Mehldau ha un pianismo perfetto che rasenta lo stucchevole, con un voicing molto accurato, quasi studiato, troppo preparato.
Avevo già sperimentato questa sua attitudine in The Art of the Trio, Vol. 3: Songs, consigliatami da un folle quanto ottimo commesso del Ricordi di via Orlando, qui a Roma: Mehldau ha un pianismo perfetto che rasenta lo stucchevole, con un voicing molto accurato, quasi studiato, troppo preparato.
Però a volte sembra un pianismo ricalcato, come se si credesse di sentire Bill Evans, senza però quella disperazione che attanagliava il grande pianista davisiano (e magari si potrebbe dire che in certi momenti era Davis ad avere un trombismo evansiano).
Ecco, se dovessi usare una similitudine: con Mehldau viaggi comodo in carrozza, apprezzi il paesaggio, leggi un buon libro, hai una confortevole conversazione, ti riposi dieci minuti, degusti un buon vino bianco barriccato... Keith Jarrett, invece, il paesaggio te lo dipinge, te lo scartavetra contro: ti costringe a fermare il treno col freno d'emergenza, ti obbliga a seguirlo, ti fa vedere strani e nuovi alberi in un bosco che stava sempre sotto il tuo grugno ma di cui ignoravi l'esistenza. Jarrett inventa, codifica, ti perseguita, ti riempie di cose e ti schiaffeggia perché ti sei distratto un microsecondo... Mehldau ti accompagna, dolcemente, con tecnica notevole, con idee rischiosette ma non troppo, con strumentisti eccezionali (il quasi drum'n'bass duo ritmico Matt Chamberlain e Larry Grenadier, il sassofonista Joshua Redman figlio di tanto padre, un produttore sperimentatore come Jon Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Brion). Ma niente più.
Da comprare, ma col contagocce.
Però a volte sembra un pianismo ricalcato, come se si credesse di sentire Bill Evans, senza però quella disperazione che attanagliava il grande pianista davisiano (e magari si potrebbe dire che in certi momenti era Davis ad avere un trombismo evansiano).
Ecco, se dovessi usare una similitudine: con Mehldau viaggi comodo in carrozza, apprezzi il paesaggio, leggi un buon libro, hai una confortevole conversazione, ti riposi dieci minuti, degusti un buon vino bianco barriccato... Keith Jarrett, invece, il paesaggio te lo dipinge, te lo scartavetra contro: ti costringe a fermare il treno col freno d'emergenza, ti obbliga a seguirlo, ti fa vedere strani e nuovi alberi in un bosco che stava sempre sotto il tuo grugno ma di cui ignoravi l'esistenza. Jarrett inventa, codifica, ti perseguita, ti riempie di cose e ti schiaffeggia perché ti sei distratto un microsecondo... Mehldau ti accompagna, dolcemente, con tecnica notevole, con idee rischiosette ma non troppo, con strumentisti eccezionali (il quasi drum'n'bass duo ritmico Matt Chamberlain e Larry Grenadier, il sassofonista Joshua Redman figlio di tanto padre, un produttore sperimentatore come Jon Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Brion). Ma niente più.
Da comprare, ma col contagocce.
12 novembre 2009
testament
14 febbraio 2008
un valentino sublime
Questa mattina mia moglie mi ha regalato un cofanetto di Keith Jarrett contenente i due Standards e Changes.
È addirittura offensivo provare a commentare la perfezione di questo straordinario pianista, predetto da un dio e forgiato dallo spirito assoluto.
Buon ascolto.
Keith Jarrett, Jazz, Musica
È addirittura offensivo provare a commentare la perfezione di questo straordinario pianista, predetto da un dio e forgiato dallo spirito assoluto.
Buon ascolto.
Keith Jarrett, Jazz, Musica
16 aprile 2007
My song
Prendevo la prima metro, quella che alle 5,15 mi ghermiva dalla fermata Giulio Agricola: mentre preparavo l'esame universitario del momento, venivo assalito da terrificanti odori di varechina-aglio-sudore, e poi arrivavo a via Asiago verso le 6,00, accompagnato dalle prime note di Keith Jarrett.
A quei tempi, Radio Tre usava il suo struggente Country come "riempitivo" (dal cd che porta il titolo My song, un'altra ballata strepitosa); pensate voi che qualità poteva avere quest'emittente, da poter usare questa meravigliosa ballata come musichetta buttata sornionamente là. Erano sicuramente altri tempi.
Ma io allora stravedevo per Corea e per Rea (nessuna parentela...). Certo, restai colpito da come Moretti (a me antipatico) abusò il Primo Concerto di Colonia per raccontare il monumento a Pasolini, affogato nell'immondizia dell'idroscalo di Ostia; ma in generale non sopportavo la stucchevole perfezione di Keith Jarrett. Troppo di moda, troppo esatto.
Da anni, ormai, ho fatto pace con questo genio, e quando voglio riassaporare quel modo di fare radio, quei sapori di esami rubati al sonno, quella mia incoscienza di dormire pochissimo e vivere ogni singolo secondo dei miei primi anni di lavoro, prendo una fiaschetta di varechina, un ciuffo d'aglio, un libro universitario e mi sparo quell'intero cd.
Nostalgia, Musica, Keith Jarrett
Iscriviti a:
Post (Atom)