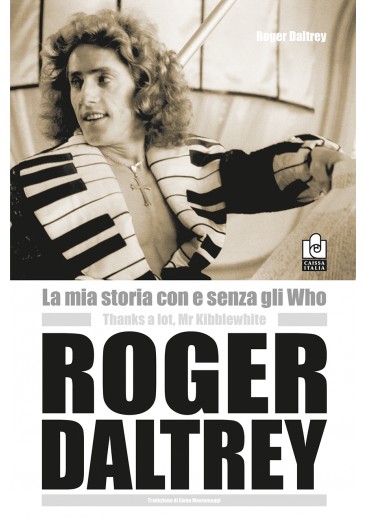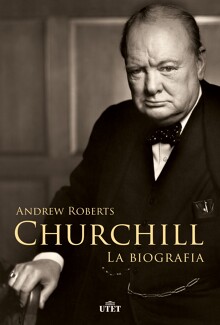Scarcity Of Miracles dei "quasi King Crimson" suona nel mio iPod da giorni, e non so ancora dire se mi sia piaciuto o no.
Premetto che ho trovato bruttini assai gli ultimi lavori dei Crimson: da ConstruKction in poi, mi sono sempre più sentito a disagio, quasi ascoltassi dei vecchietti reprobi che si ostinavano a portare avanti una Ferrari, ma al centro dell’autostrada, a tre all’ora, senza voler far passare nessuno, se non l’ombra dei ricordi.
Intendiamoci: in linea generale ha senso che un musicista termini fisiologicamente la sua parabola (Gabriel è finito da almeno quindici anni, come anche David Bowie - dai tempi di Outside); però te lo aspetti, lo accetti, e continui a comprare i suoi dischi più per affetto che per reale convinzione.
Però per Fripp è stato diverso. Per motivi storici, non affettivi: quando lo davi per finito, BUM!, tirava fuori dal suo cervellone qualcosa di nuovo, di diverso, di innovativo. Difficile elencare, cioè, quante volte il megaFripp sia passato dalla polvere all’altare, ma ogni volta è accaduto con rara eleganza, con un senso della misura veramente esaltante, con una capacità di rinnovare tutto quanto toccava, pur restando ormai dentro quelle sue scale, quei suoi suoni, quegli accordi e quei ritmismi che ti fanno dire “questo è Bob, il Re Cremisi di sempre... ma anche di più”.
Difficile, insomma, essere all’avanguardia, saper pure invecchiare e nello stesso tempo continuare ad innovare un panorama musicale mondiale veramente sciapo e asfittico da almeno dieci anni (se non di più). Eppure Fripp ci è sempre riuscito; eppure in questo Scarcity ci son cose che non mi tornano.
La prima, è la voce di Jakko: insopportabile. Sembra quasi l’acido ascorbico: rende i sapori tutti uguali, che sia dentro una lattina di buona birra o in un succo di frutta; alla fine, hanno sempre lo stesso sapore. Voce che peraltro manca totalmente di elegia (come quella di Lake), di locale fumoso (Haskell), di cazzone passato per caso (Burrell), di perfezione assoluta (Wetton, dio lo benedica sempre), di strafottenza illuminata (Belew).
La seconda, è il bassismo stralunato di Levin. Per carità non mi aspettavo il suo solito slapping: ma ogni tanto va dove Harrison non arriva, oppure non lo completa come sapeva solo fare con Bruford (non parlo di Mastellotto, perché per me non è stato un batterista, ma uno scaricatore di porto… con tutto il rispetto…).
La terza è Harrison: sembra che Fripp lo abbia piazzato solo per dargli un po’ di spazio. Non c’è il mistico e canonico batterismo Crimsoniano, che assume il ruolo di vero e proprio strumento musicale. Harrison sa fare cose egregie, per carità (cfr i Porcupine Tree); qui, però, si limita a una presenza professionista ma non professionale.
La quarta è Fripp stesso: non c’è un solista in linea che sia uno. Bob ci ha sempre abituati a chitarre perfette, perfettamente messe in asse dentro strutture perfette (a dirla pesante: è quadrato com'è quadrato Bach... ma che quadratura!). A differenza di tutti i slasher, Fripp era così slasher da non farlo mai capire fino in fondo (forse in Larks parte III lo si percepisce totalmente; altro che Schizoid o Starless). E proprio per questo sapeva quando zittire la sua chitarra e quando farla parlare. Qui, Fripp sembra voler evitare la sua perfezione, dando troppo spazio a soundscape e poco al suo suono-sega, ai suoi temporanei periodare così intriganti.
Last but not least, il sopranino di Collins. Insopportabile. Te lo trovi ovunque come il prezzemolo. Ora, secondo le note di copertina, il progetto sarebbe frutto di continue improvvisazioni (come, in fondo, è sempre stato l’approccio crimsoniano): ma qui qualcuno doveva dire a Collins di darsi una calmata; oppure in fase di postproduzione, il buon Fripp doveva tagliuzzarlo a dovere (per dirne una: il Clemons di Jungleland è frutto di postproduzione, altroché). Macché, è un continuo giochicchiare di scalette insopportabili.
Paradossalmente, dopo tutte queste mie mazzate, il cd va bene per chi cerca il Sylvian meno serioso (la title track è un ottimo esempio, ed è l'unica cosa che salverei), per chi ama il pop più sofisticato e ricercato, per chi ama quell’insostenibile mondo dell’inutile chiamato “meditazione”.
Ma per chi ama il Fripp che sa sempre guardare oltre, il Fripp che osa, il Fripp, insomma, che atterra e suscita, che affanna e che consola… meglio lasciar perdere.