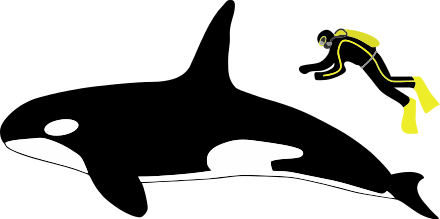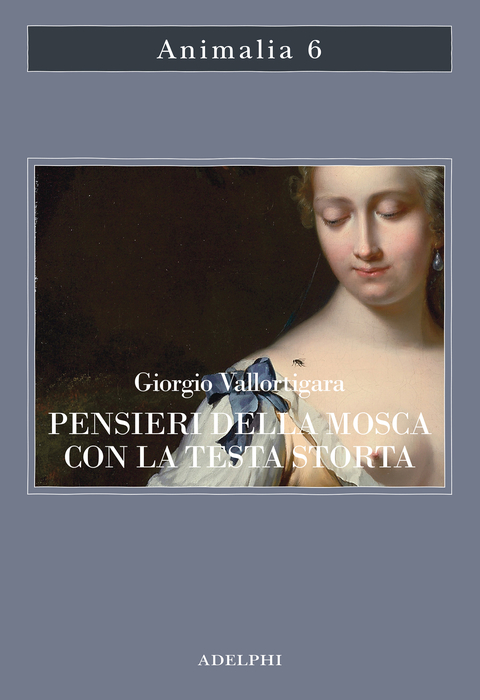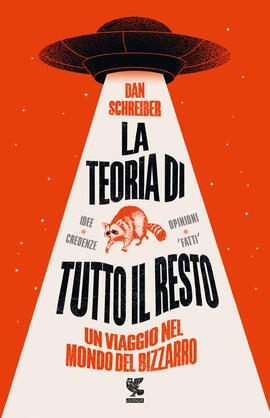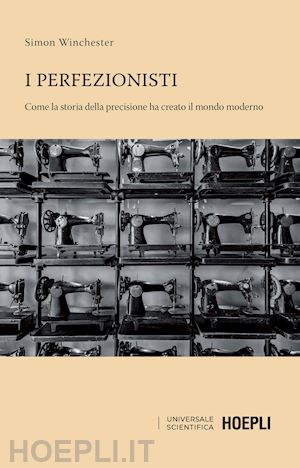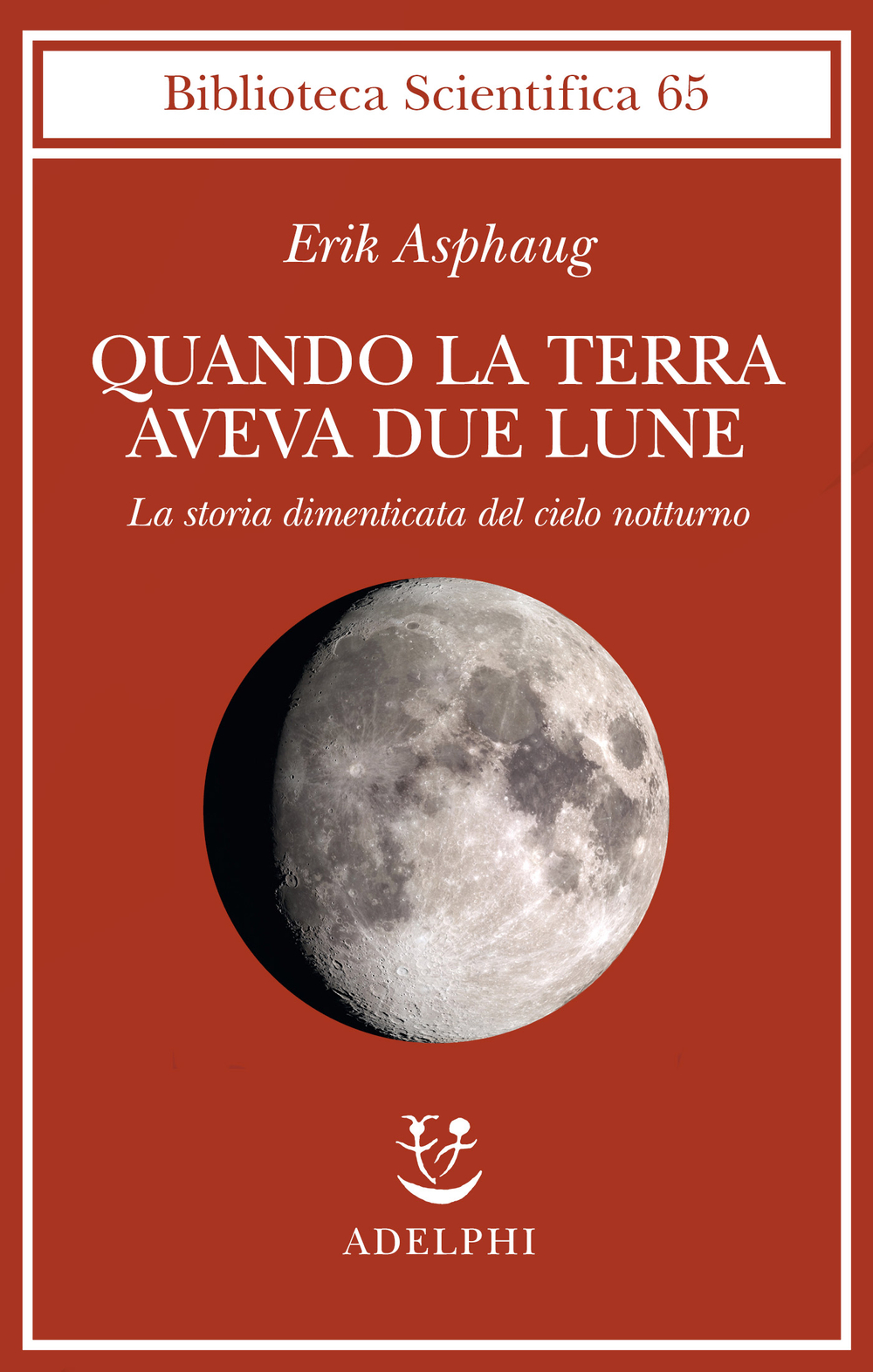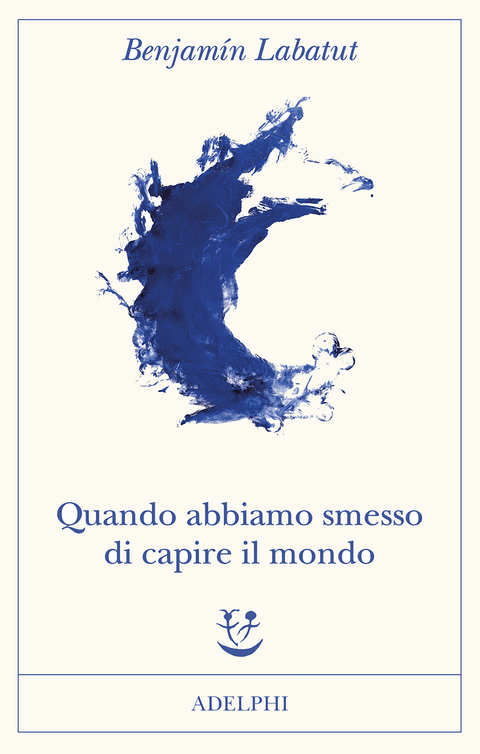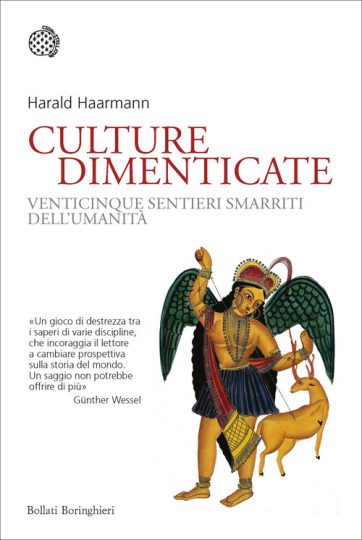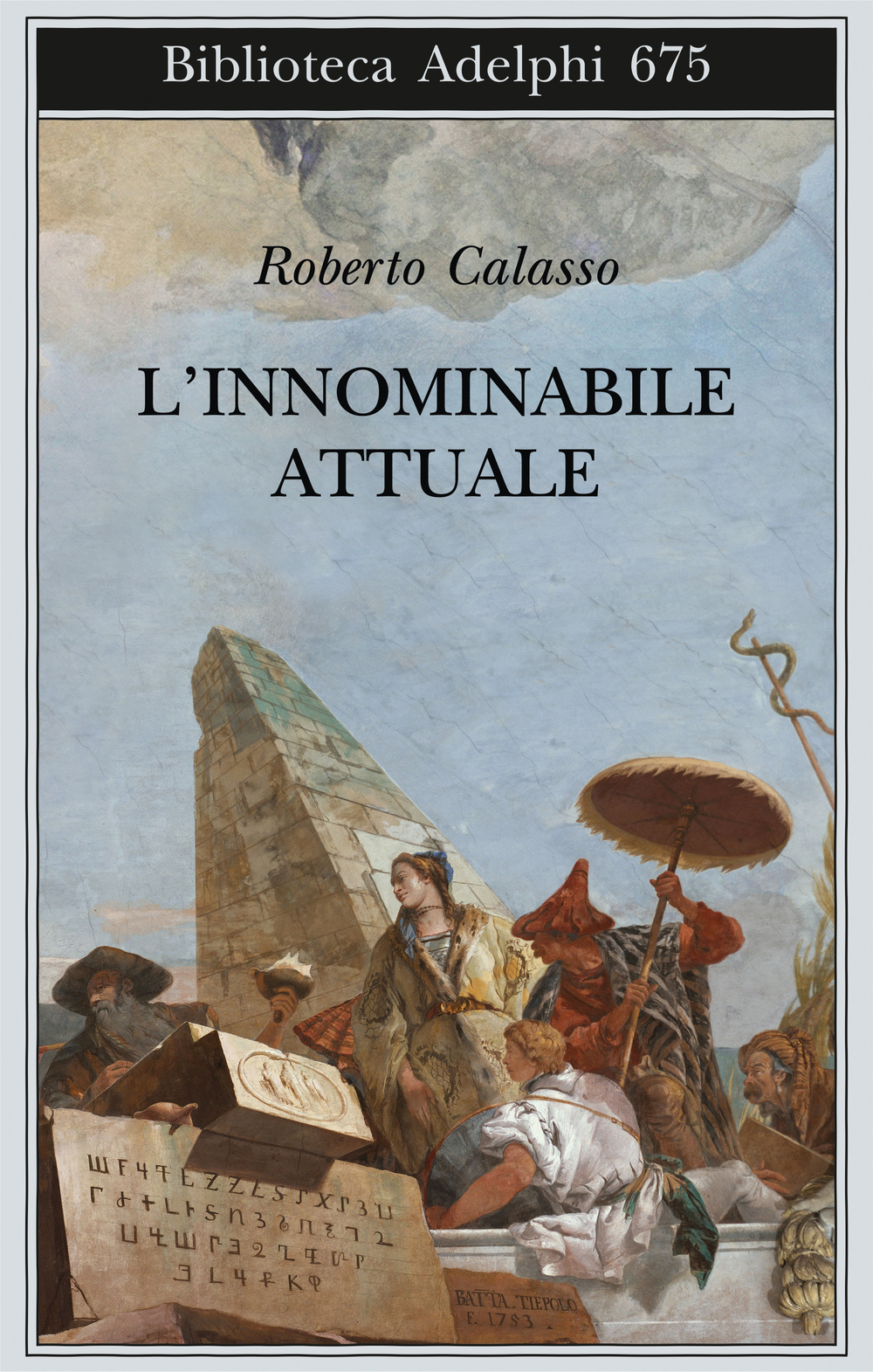Non soltanto la Natura seleziona le migliori api, quelle che sanno resistere alle malattie e che riescono a produrre più miele.Al giorno d'oggi, la Natura seleziona anche gli apicoltori, perché sempre meno persone decidono di proseguire il loro cammino in mezzo a tutte queste tempeste
13 dicembre 2024
LA VITA SEGRETA DELLE API di Marco Valsesia (Longanesi)
17 ottobre 2024
IL CUORE SELVAGGIO DELLA NATURA di David Quammen
Ci sono ancora grandi paesaggi e grandi possibilità in tutto il mondo. Il cuore selvaggio della natura è intrinseco all'estensione, alla connessione, alla diversità e ai processi dei grandi ecosistemi. Finché noi esseri umani riconosceremo questa realtà, la rispetteremo e ci sforzeremo di preservare quegli elementi tramite iniziative appassionate e sagge come quelle che ho descritto nel libro, in mezzo a luoghi magnifici che comprendono quelli ritratti in queste pagine ma anche altri, il cuore continuerà a battere
18 maggio 2024
l'oltre di OPPENHEIMER
Tra le pochissime opere recenti che sono riuscite a sfidare queste allegoriche Colonne di Ercole c’è Oppenheimer (2023), l’eccellente film di Christopher Nolan che ha vinto legittimamente gli Oscar più importanti.
Ha la capacità di fare vedere e sentire (nel senso epidermico del termine: gli inglesi direbbero feel) i sentimenti, i tormenti, la genialità, le paure, i mostri interiori dei singoli personaggi.
Sceneggiatura, musica, montaggio e fotografia sono al servizio dell’anima, sia nella sua forma interiore che in quella espressiva. La cosa incredibile è che sono pregi “economici”, che non hanno bisogno del budget speso per produrre questo capolavoro: significa, insomma, che il contributo umano alla riuscita di questo film è ben superiore a quello tecnologico (al netto che il regista è noto per usare effetti visivi/analogici invece che speciali/digitali).
Lo dico perché chi mi contestato la stroncatura del film di Cortellesi ha aggiunto che con quei budget non puoi fare di più. Non è vero! E Oppenheimer ne è la prova! Funziona per le qualità attoriali, per la sceneggiatura piùccheperfetta, per la direzione delle luci sempre puntuale, per il montaggio attento a ogni singola sfumatura, per la musica e i suoni - composti coerentemente e incastonati al momento giusto.
09 marzo 2024
ORCHE, DI MARE, DI LIBRO E DI CINEMA
Piccola premessa: è impossibile fotografare le balene mentre si accoppiano. Così impossibile che questa foto, così dolce e sorprendente, ha immediatamente fatto il giro del mondo: Lyle Krannichfeld e Brandi Romano hanno catturato due megattere mentre fanno l’amore.
Solo dopo, ad una visione più attenta, si è scoperto che a scambiarsi le effusioni sono due maschi. Quello che per certi ominicchi è contronatura, in realtà (e per fortuna) è Natura. Sempre.
Da un mammifero acquatico di eleganti movenze (benché Melville considerasse “pesci” le balene), passiamo a un mammifero acquatico di elegante ferocia: l’orca, definita maldestramente “assassina” (“killer”, per gli anglofoni).
Quindici giorni fa, è uscita un'argomentata polemica sul presunto inedito di Stefano D’Arrigo, finora noto solo per il suo poderoso Horcynus Orca (1975), romanzo post-verista di indubbio fascino.
Neanche a farlo apposta, un mese fa, in Sud Africa, è stata ripresa un’orca mentre strappava il fegato a uno squalo nel giro di pochi minuti.
Non è la prima volta che càpita. La tecnica venatoria di questo meraviglioso mammifero consiste nell’approfittare di un “difetto di fabbrica” degli squali: se li giri su loro stessi, vanno in tanatosi, rendendoli indifesi e inoffensivi quel tanto che basta per farne scempio. Per carità, un essere umano neanche riuscirebbe a fare il solletico a uno squalo… ma l’orca è l’orca.
Al che, potere della memoria, viene immediatamente in mente una scena simile da L’orca assassina (1977, una quasi risposta allo Squalo), quando uno dei protagonisti sta per essere ucciso da uno squalo e viene appunto salvato dalla possanza di un’orca di passaggio, che scaraventa per aria il perfido pescione, per poi farlo a pezzi.
Un film discreto, molto amato dal protagonista (Richard Harris), che vede l’esordio della bellona Bo Derek, ben prima di esplodere con 10 (1979). Esordio sfortunatissimo, va detto: a metà film, l’orca le spezza una gamba; alla fine, non paga, gliela divora, gesso compreso.
Il regista Michael Anderson lo conoscete per un mucchio di film eterogenei: uno di questi, La fuga di Logan (1976, quasi risposta a L’uomo che fuggì dal futuro), vede il quasi esordio della bellona Farrah Fawcett: anche in questo caso, il suo personaggio muore male, molto male.
07 settembre 2023
LA VITA PERFETTA DI WILLIAM SIDIS di Morten Brask (Iperborea)
Secondo Wikipedia, William Sidis sarebbe stata la persona col più alto QI mai misurato nella storia. E già questo biglietto da visita invoglierebbe a saperne di più, se non altro perché sono certo che in molti si aspetterebbero caratteri tipo lo Spencer di “Criminal Minds” o lo Sheldon di “The Big Bang Theory”. E, invece, è stato un personaggio abbastanza refrattario sia alla notorietà che all’usare le proprie facoltà perlomeno creando una propria dimensione felice, una sorta di soddisfazione personale assoluta.
Ora, il rifiuto della vanità ha un suo senso, quello dell’arricchimento economico pure; ma non si capisce perché questo romanzo debba esaltarne addirittura la tendenza all’autocommiserazione e alla mortificazione personale. Fatto sta che le prodezze di Sidis sono accessorie alla narrazione e certe sue scelte illogiche vengono narrate con un’aura di eccessiva nobiltà.
Non mi aspettavo nulla da questa biografia romanzata, però ho faticato non poco ad arrivare alla fine. Lo stile dell’autore è sicuramente liquido al punto giusto, ma è la trama che proprio non mi ha preso. La tecnica dell’andare avanti e indietro nel tempo funziona abbastanza, anche se ogni tanto bisogna rileggere il titolo del capitolo per capire a che punto siamo. Infine, non ho capito se la scelta di ipotizzare la sua morte così prematura come conseguenza di un’aggressione sia una speculazione artistica o una ricostruzione successiva a qualche approfondimento.
Insomma, è un libro che scivola via, lasciando ben poco.
30 agosto 2023
PENSIERI DELLA MOSCA CON LA TESTA STORTA di Giorgio Vallortigara (Adelphi)
La domanda di partenza di questo piccolo gioiello è "quando possiamo parlare di coscienza"?
La risposta la copioincollo dalla sinossi, per evitare di fare un torto all'autore con un mio riassunto superficiale:
"Distaccandosi dai modelli oggi più comuni nell’ambito delle neuroscienze e della filosofia della mente, egli avanza la tesi originale che le forme basilari dell’attività cognitiva non abbiano bisogno di grandi cervelli, e che il surplus neurologico che si osserva in alcuni animali, tra cui gli esseri umani, sia al servizio dei magazzini di memoria e non dei processi del pensiero o della coscienza. Il substrato più plausibile per l’insorgere di quest’ultima va piuttosto ricercato in una caratteristica essenziale delle cellule, la capacità di sentire. Una capacità che si sarebbe manifestata per la prima volta quando, con l’acquisizione del movimento volontario, gli organismi elementari hanno avvertito la necessità di distinguere tra la stimolazione prodotta dalla propria attività e quella procurata dal mondo esterno, l’altro da sé"
Fidatevi, è un libro bellissimo, di quelli che personalmente ho messo nell'area "rileggilo meglio!".
È un viaggio nel mondo della neuroscienza, nei cervelli di molti animali (alcuni insospettabili), nell'evoluzione delle scienze cognitive.
Un libro sicuramente complesso, ma non complicato, in cui l'autore dimostra pazienza e rispetto nei confronti del suo lettore, senza mai spingere l'acceleratore della sapienza, proponendo per gradi (sempre argomentati e documentati) una progressione di considerazioni veramente avvincente.
29 agosto 2023
BALLANDO NUDI NEL CAMPO DELLA MENTE di Kary Mullis
Premio Nobel della Chimica 1993, Kary Mullis è un personaggio che conoscete inconsapevolmente tutti per un motivo: il tampone per rilevare il Covid è una sua invenzione; o meglio, lo è la reazione chimica necessaria per rilevare questa ed altre patologie.
Fatto sta che più che uno scienziato, Mullis sembra uscito da un episodio di "Ritorno al futuro": passa con estrema disinvoltura a discettare di ragni velenosi o di astrologia, di AIDS o del processo a O.J. Simpson, di effetto serra e di capacità telecinetiche. La vera vittima di Mullis è la scienza, i suoi dogmatismi e le sue strade obbligatorie.
Una quasi-autobiografia divertente e curiosa, che alla fine mi ha lasciato un enorme quesito addosso, e che (per ora) nessuno mi ha chiarito: il procione alieno che avrebbe incontrato Mullis di notte in un bosco ha ispirato il Rocket dei "Guardiani della Galassia"?
COME FUNZIONA DAVVERO IL MONDO di Vaclav Smil (Einaudi)
C'è un elemento fondamentale che manca totalmente agli ecologisti quando argomentano le loro lotte: il contesto. Possono avere tutti i possibili dati a loro favore (e li hanno!), tutte le previsioni che li supportano (e le hanno!); ma senza il contesto, le loro parole sembrano urla, sembrano isteria, sembrano una religione. Finché non si renderanno conto che il contesto dovrà far parte di ogni singola parola che vorranno proferire in pubblico, verranno solo ascoltati, ma non seguiti o imitati.
E questo ottimo libro di Vaclav Smil è un eccellente strumento per stabilire le giuste connessioni con il contesto. Smil non si limita solo a presentare numeri e previsioni: si preoccupa in realtà di contestualizzarli (appunto) e di indicare necessità, vie senza uscita, rimedi a lunghissimo termine. Smil smonta alla base le convinzioni su alcune materie prime (non sono sostituibili), su alcune invenzioni ecologiche (il costo di un'auto elettrica fa impressione), su alcuni cibi (come consumatori "dannosi", onnivori e vegetariani quasi pari sono).
È un libro ricco, denso, a tratti faticoso perché colmo di dati e di informazioni, che dovrebbe essere considerato come un manuale, come una guida, come un compendio da leggere e rileggere prima di fare un convegno o un discorso politico sulla fine del Mondo.
28 agosto 2023
LA TEORIA DI TUTTO IL RESTO di Dan Schreiber (Guanda)
Ho sempre amato questi libri antologici sulle stranezze, ma non sono mai riuscito a ricordarne il contenuto un minuto dopo averli terminati. È come se tanta messe di informazioni e di risate impedisse di memorizzarne qualche passaggio o almeno qualche capitolo.
Per carità, è un mio limite. Però, nel caso di questo libro di di Dan Schreiber, è un rischio concreto, perché si passa da grandi argomenti ad altri meno interessanti nel giro di poche righe, per quanto siano supportati da una buona scrittura e da un'avvolgente aneddotica.
Si parla di: Kary Mullis (il cui procione alieno ricorda il Rocket dei "Guardiani della Galassia"), Wolfgang Pauli, Tu Youyou, i Beatles, Rosemary Brown e i "suoi" morti, le ultime parole proferite prima di morire, Novak Đoković (proprio lui), viaggiatori del Tempo, il Titanic (forse il capitolo più riuscito), la comunicazione animale, le piante investigative ("La traccia verde", uno sceneggiato della RAI del 1975, ne parlò in tempi non sospetti), maghi, fantasmi, alieni, la Terra Cava, Marte, Nostradamus...
Grande ironia, tempi narrativi studiati, cultura immensa e una serie infinita di analogie e gradi di separazione.
Un bel libro, ripeto, ma che ho dimenticato in fretta.
DEMONI, VENTI E DRAGHI di Amedeo Feniello (Laterza)
Se avete tempo e voglia, ne ho parlato qui, su "Digital World" (anche se non mi piace il montaggio); qui, su YouTube; qui, sulla mia rassegna stampa settimanale.
11 febbraio 2022
note a margine del bellissimo LA VITA SEGRETA DEGLI UCCELLI (La Nave di Teseo)
Insomma, una rappresentazione complessa ed eterogenea che proprio non ti aspetti da Madre Natura. Oppure, fai finta di non aspettartelo; perché, in realtà, questa è Madre Natura.
Voglio dire che da quando è esploso il "fenomeno Greta" (su cui sembra quasi impossibile esprimere riserve... notare che ho scritto "su cui" e non "di cui"), il vocabolario ecologico - e una diffusa grammatica colpevolistica, si sono riempiti anche di frasi senza senso e concetti illogici.
A Madre Natura frega nulla di un'inondazione, di un incendio, dello scioglimento dei ghiacci, di una raffica di vento mortale, di un'estinzione. E non frega nulla, perché Madre Natura è anche quello. Madre Natura è l'esistente, punto. Madre Natura è l'essenza di questo esistente. Punto.
Attenzione, non sto facendo filosofia spicciola, perché non ne sono capace e non mi va. Voglio solo dire che le nostre preoccupazioni sui problemi climatici sono autoreferenziali e nel contempo deresponsabilizzanti. Autoreferenziali, perché a noi interessa colpevolizzarci in maniera astratta, e credere che ci sia una fine della Natura (e un fine della Natura), esclusivamente in base ai soli effetti che avrebbe su di noi, mentre - come ho scritto sopra - Madre Natura sussisterebbe sempre.
Deresponsabilizzanti, per due motivi.
Il primo: è "l'altro" che deve fare qualcosa, è l'"altro" che ha la colpa di questa fine, è l'"altro" che usiamo come spauracchio per giudicare tutti.
Il secondo motivo, vede questo "altro" cui concediamo di diventare un "noi", solo se si attiene a rimedi ambientalistici decisi da noi, in cui comunque siamo noi che stabiliamo come va "salvata" Madre Natura da noi stessi. E se l'"altro" inquina perché è povero per causa nostra, non cerchiamo di rimediare al nostro colonialismo intellettuale, ma lo costringiamo a "integrarsi" tra di noi.
Altrimenti, se fosse "solo" un problema di diffusi comportamenti sbagliati, Greta sarebbe andata anche in Cina, in India o in Russia, tre delle prime cinque nazioni che stanno inquinando il Pianeta.
L'altra nazione è l'America; l'altra ancora è internet, anche se chi ama "spiegare bene" tutto sia convinto di non sapere che internet inquini, e tanto pure.
Che c'entra, quindi, questo bellissimo libro? C'entra, perché dimostra appunto quanto Madre Natura sia feroce, cinica, spietata, anche e soprattutto quando è bella.
La grande bellezza di Madre Natura è ben altro rispetto alla retorica volontà di ricondurla solo all'immaginario Disney (che pur amo, purché inserito nel giusto contesto).
Se noi volessimo vivere veramente secondo Natura, dovremmo fare più di un passo indietro e ridurci anche a comportamenti che la nostra etica considera, invece (e ipocritamente), esecrabili.
Per carità, gli esseri umani sono stronzi tra loro, e parecchio pure; ma questo non toglie che mitizzare la Natura è un'operazione rischiosa e controproducente.
Con questi ragionamenti, non mi sto sottraendo dalla responsabilità umana di aver distrutto l'ambiente in cui vive e di perpetuare insistentemente la volontà di distruggerlo.
Ma pregherei tutti a ragionare in altra maniera: stiamo distruggendo noi stessi solo con noi stessi; i movimenti ecologisti sono belli e utili, ma non hanno colto il nodo della questione; tutto questo a Madre Natura non può frega' de meno.
24 gennaio 2022
I PERFEZIONISTI di Simon Winchester (Hoepli)
Si parla di: John Wilkinson, con il ferro ebbe un rapporto quasi sentimentale; Joseph Bramah, inventore della stilografica, dei bariloni per tenere la birra fresca, dei lucchetti, dei contabanconote; Henry Maudslay, con il suo micrometro arrivò quasi all'accuratezza assoluta; Honoré Blanc, padre del fucile moderno; Joseph Whitworth, introdusse lo standard di misurazione delle viti; Rolss-Royce e Ford, due modi opposti di concepire l'automobile; Frank Whittle, inventore del motore a reazione; Leitz Oskar Barnack, ovvero la Leica, la macchina fotografica più migliore ancora assai; Jim Crocker, "aggiustò" il telescopio Hubble; il GPS; i chip moderni.
21 luglio 2021
QUANDO LA TERRA AVEVA DUE LUNE di Erik Asphaug (Adelphi)
Forse perché in fondo lei sta lassù, ma non troppo distante da noi; sicuramente perché da Méliès in poi, la Storia del Cinema l'ha raccontata in mille modi diversi, tutti coinvolgenti e tutti affascinanti.
Però credo che il libro si perda un po' quando l'autore, generando troppe aspettative e indicando troppe strade senza fine, non conclude nitidamente il suo viaggio. E non è che non lo faccia perché comunque i dubbi restano e fanno parte del mestiere: non lo fa perché sembra quasi voluto, come fosse uno studiato "difetto" stilistico.
08 febbraio 2021
QUANDO ABBIAMO SMESSO DI CAPIRE IL MONDO di Benjamín Labatut (Adelphi)
21 gennaio 2021
CULTURE DIMENTICATE di Harald Haarmann (Bollati Boringhieri)
Ma in realtà è molto di più: il lettore conoscerà culture sconosciute ai più, oppure culture già note ma da un punto di vista totalmente diverso, addirittura imprevedibile.
Per tacere dei nostri etruschi, le cui abilità artistiche, mitologiche e architettoniche sono state masticate a più non posso dagli antichi romani; con tanto di gustoso riscoprire un vocabolario etrusco che ci influenza ancora oggi, e di molto pure.
31 dicembre 2020
L'INNOMINABILE ATTUALE di Roberto Calasso (Adelphi)
Già, solo su questo titolo potremmo discettare per ore, tale è la sua capacità di evocare argomenti, pensieri, suggestioni e filosofie, anche indipendenti dalle intenzioni di Calasso stesso.
Premesso ciò, il saggio è suddiviso in soli tre capitoli, che suggerisco di leggere singolarmente e senza pause, e che qui racconto partendo dall'ultimo.
Il terzo è una chiosa quasi disarmante, racchiusa in due sole pagine, velatamente allusiva a un momento del sesto pannello, quelle Folie Baudelaire che tanto ci avevano portato nella profondità oscura ma non ombrosa del poeta francese. Chiosa che rimanda al presente, all'attuale insomma, innominabile o no che sia. Non posso certo citarne qualcosa, anche per non rovinarvi la sorpresa insita nella sua conclusione.
Il secondo capitolo è un ordinato quanto devastante elenco di eventi collaterali al lento procedere della Seconda Guerra Mondiale, all'annientamento del popolo ebraico, a una serie di rimandi più o meno concettuali a buona parte dei pannelli più teorici di questa opera incredibile di Calasso.
Letto senza fermarsi mai, è un capitolo che elenca la debolezza insita dell'Homo saecularis, ormai ben lontano da quelle nobili suggestioni che avevamo incontrato negli altri testi di Calasso.
Durante la descrizione delle ignominie tedesche, compare già un ipotetico link tra il precedente Cacciatore Celeste e il prossimo Libro di tutti i libri, quando cioè scrive: "I nazisti erano la tardiva rappresaglia del mondo animale verso la specie che ne aveva violato l'ordine; e gli ebrei erano i rappresentanti eletti di quella specie". È un passaggio che resta fermo su se stesso, perché la sospensione narrativa e quella emotiva sono tali che passa quasi inosservato.
Il primo capitolo è folgorante: non c'è paragrafo, riga, parola, spazio, che non siano condivisibili, che non costringano a una lettura-rilettura, sia per la densità che per l'acume con cui viene raccontato questo momento attuale, questa volta decisamente innominabile: "La sensazione più precisa e più acuta, per chi vive in questo momento, è di non sapere ogni giorno dove sta mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le prospettive oscillano. Allora si avverte con maggiore evidenza che ci si trova nell'«innominabile attuale»".
E l'idea di come proceda questo mondo non è decisamente un complimento: "È un mondo frantumato anche per gli scienziati. Non ha un suo stile e li usa tutti".
A forzare la mano, un'affermazione del genere fa venire in mente che in una parte consistente della biblioteca adelphiana, la frantumazione - la quantizzazione, insomma - sia una costante editoriale, e non solo della Biblioteca Scientifica. Come se da sempre Calasso abbia sentito e senta l'esigenza di ricomporre questa frantumazione, di darle un senso, un'origine e un significato.
Altro elemento nodale dell'attuale è il terrorismo: "Fondamento del terrore è l'idea che soltanto l'uccisione offra la garanzia del significato. Tutto il resto appare labile, incerto, inadeguato [...] Come ogni pratica sacrificale, il terrorismo islamico si fonda sul significato. E quel significato concatena ad altri significati, tutti convergenti verso lo stesso motivo: l'odio per la società secolare".
Società secolare che "ha una paura tremenda di quella che è stata la sua più grande scoperta: l'alleggerimento, lo svincolarsi dagli obblighi rituali e confessionali. Invece di apprezzare questa situazione sospesa e prenderla come possibile inizio di nuove mosse, si precipita a ingabbiarsi nelle cause, buone o pessime che siano. E quelle cause sono innanzitutto palliativi".
Cause che sono palliativi. Come questa: "I secolaristi si accorsero che non erano soli. E che non occupavano tutto il mondo. Le procedure si applicavano ovunque, ma i secolaristi vivevano solo in una certa parte del pianeta - e neppure la maggior parte. Si sentirono improvvisamente assediati da stranieri, che chiamavano migranti. I quali volevano usare le loro procedure, ma continuavano a guardarli con l'occhio infido di chi si sente altrove".
Non resta che rivolgersi alla religione, alle chiese, alla Chiesa: "Homo saecularis applica precetti di eredità cristiana, ammorbiditi e edulcorati. Soluzione tiepida e pavida, si combina, in senso inverso, con il movimento in corso nella Chiesa stessa, che cerca sempre più di assimilarsi ad un ente assistenziale. Il risultato è che i secolaristi parlano con una compunzione da ecclesiastici e gli ecclesiasti ambiscono a farsi passare da professori di sociologia".
Il pensiero della società secolare, insomma, "è ciò che rimane dopo un processo di svuotamento progressivo, operante da un certo numero di millenni".
Non se la passa bene neanche la democrazia: "Rispetto a tutti gli altri regimi, la democrazia non è un pensiero specifico, ma un insieme di procedure, che si pretendono capaci di accogliere in sé qualsiasi pensiero, eccetto quello che si propone di rovesciare la democrazia stessa. Ed è questo il suo punto vulnerabile, come si dimostrò in Germania nel gennaio 1933 [...] La democrazia formale è senz'altro la più perfetta versione della democrazia, ma anche la più inapplicabile. Soprattutto quanto è stato superato un certo meridiano della Storia e le pressioni demografiche, etniche, psichiche diventano sopraffacenti. Allora risorge la chimera della democrazia diretta. Suo fondamento è l'odio per la mediazione, che facilmente diventa odio per il pensiero in sé, indissolubilmente legato alla mediazione".
L'innominabile attuale è anche (nella) tecnologia: "All'inizio del nuovo millennio, quando si stabilizzò l'impero digitale, divenne chiaro che controllo significava innanzitutto controllo dei dati. E la situazione si rovesciò. Quei dati non venivano più estratti a forza dall'alto, ma spontaneamente offerti dal basso, da innumerevoli individui. Ed erano la materia stessa su cui esercitare il controllo". Chissà se abbiamo capito quello che ho appena trascritto, perché è esattamente quello che andrebbe detto.
Bellissimo l'apologo sugli hacker, che ho citato anche in questa puntata di WikiRadio, andata in onda su Rai Radio3 l'11 novembre 2020: "La traduzione di hacker come «pirata informatico» è imprecisa e sviante perché ignora l’aspetto di operazione sulla forma che è insito nel termine inglese. Hacker è qualcuno che taglia, intacca, e - eventualmente - smonta, ricompone, frantuma una forma. Senza questa azione sulla forma non si dà hacking; la pirateria invece è un puro atto di aggressione e sottrazione […] Ogni software richiede operazioni di codifica universale e onnilaterale, Ogni codifica è una sostituzione. Ma anche la codifica può essere sostituita. E magari da un «codice maligno», come si usa dire nel gergo informatico. È questo il karman della digitalità. Chi di sostituzione ferisce, di sostituzione può facilmente perire".
Potrei scrivere decine e decine di citazioni vere e attuali; ma preferisco congedarmi con quelle due che ci riguardano da vicino, a noi pionieri della tecnologia, ma soprattutto ai ragazzi che sono cresciuti e cresceranno circondati da questo impalpabile attuale: "Un immane sconvolgimento psichico, che nessuno sarebbe in grado di circoscrivere, è stato provocato - e continua ad esserlo - dalla confluenza fra il digitale e il digitabile. Il sapere assume la forma di una singola enciclopedia, in perenne, proliferante espansione e in linea di principio digitabile. Enciclopedia che giustappone informazioni impeccabilmente veritiere e informazioni infondate, ugualmente accessibili e sullo stesso piano. Ciò che è digitabile appartiene a ciò che è famigliare, perché trattabile con affettuosa noncuranza. Il sapere perde prestigio e appare come fatto di voci - nel senso di voci di un'enciclopedia e di voci vaganti, incontrollabili".
L'affondo finale è disarmante (che poi spettacolizzare questa citazione con una premessa simile, conferma il postulato della citazione stessa): "C'è poi un altro aspetto, non meno dissestante, della disponibilità informatica. Chiunque si è trovato a poter produrre, senza alcun vincolo, parole e immagini, virtualmente divulgabili ovunque, per un pubblico illimitato. Tanto è bastato per suscitare un diffuso delirio di onnipotenza, ma non più come fenomeno clinico. Al contrario, come arricchimento della normalità. La mitomania è entrata a far parte del buon senso".
- La rovina di Kasch (1983)
- Le nozze di Cadmo e Armonia (1988)
- Ka (1996)
- K. (2002)
- Il rosa Tiepolo (2006)
- La folie Baudelaire (2008)
- L'ardore (2010)
- Il Cacciatore Celeste (2016)
- L’innominabile attuale (2017)
- Il libro di tutti i libri (2019)
- La Tavoletta dei Destini (2020)
- Opera senza nome (2024 - postumo)
28 dicembre 2020
THE MIDNIGHT SKY di George Clooney
È un film strano questo di (e con) George Clooney, perché ha molti difetti e pochi pregi; eppure resta appiccicato nella mente per più tempo rispetto alla media dei film di media qualità.
La trama, a grandissime linee (evito spoiler, tranquilli). La Terra non se la passa così bene, tanto che la gente viene evacuata per chissà dove. Lui è uno scienziato totalmente dedito alla scienza, con un grande avvenire dietro le spalle e un mucchio di rimorsi che lo erodono nel presente: minato da un cancro all'ultimo stadio, anziché partire con tutti, decide di restare in un non meglio identificato osservatorio (una sequenza fuori campo lo colloca in Artide, mentre alla fine del film lui stesso dice di essere in Antartide). Parallelamente a questa storia, un'astronave in missione su una luna di Giove sta tornando sulla Terra. E qui mi fermo, altrimenti vi rovino tutto.
La trama sa di già visto, così tante volte che ho perso il conto delle numerose citazioni più o meno volontarie. Sicuramente il sottotesto ecologico è meno noioso del solito, senza corollari nevrotici alla Greta insomma.
Lui è bravo, indiscutibilmente bravo, sia perché non gigioneggia mai, sia perché riesce a rispettare il suo ruolo senza presidiarlo con una regia invece discreta e collettiva.
La bambina è fenomenale, soprattutto perché fa la bambina senza esagerare, con un autocontrollo decisamente "adulto" ma non stucchevole.
La sceneggiatura è il suo punto debole. È come se avesse sempre un frame in più, quasi ridondante: rende l'insieme lento, inutilmente lento. Si può fare fantascienza adulta senza rompere le palle allo spettatore come appunto accadeva con il Solaris originale.
Le musiche di Alexandre Desplat non sono poi così ficcanti: ricordano troppo il Sakamoto di Bertolucci come anche l'Hans Zimmer della Sottile Linea Rossa.
La fotografia è netflixiana: pastosa, appiccicata, digitale e quindi senza profondità. Ottime le inquadrature e le scelte di campo, ma rese vane da luci spesso plastificose. Nulla da dire sulle evoluzioni spaziali, forse inutili ma pregevoli... e debitrici della lezione di Gravity, cui Clooney per primo ammette di dovere qualcosa. A latere: tranne la scena dell'acqua, gli esterni sono stati veramente girati al freddo (in Islanda).
L'idea proposta nel finale sarebbe verosimile nonostante nel resto del film alcuni espedienti siano tutt'altro che scientifici, inaccettabili per un film dichiaratamente "adulto": i rumori nello Spazio (dove, invece, non si può sentire niente); asteroidi grossi come una sedia che causano danni trascurabili (chiedete a quelli dell'ISS i danni che può causare una briciola di metallo); il tempo di latenza delle comunicazioni tra l'astronave e la Terra è pari a zero (solo con la Luna il ritardo è di oltre tre secondi; figuriamoci con Giove o dintorni).
Chiaramente non posso aggiungere almeno altre quattro incongruenze perché svelerebbero il finale; una quinta (decisamente imbarazzante) verrà in mente a chiunque appena svelato il destino dei quattro astronauti.
Incredibile, invece, le due invenzioni standardizzate, che vanno quasi a braccetto: le pareti "morbide" dell'astronave e una stampante 3D usata per fabbricare al momento strumenti utili alla bisogna.
Io sono convinto che se decidi di fare un film in streaming, sei quasi costretto a ragionare in maniera diversa, tenendo conto cioè che il pubblico si distrae facilmente, tra chi beve qualcosa, il salotto illuminato così così, il pigiama comodo e la coperta calda, la telefonata, le coccole, la domanda di troppo... tutti elementi che tolgono il senso del cinema "tradizionale", quello silente, quello di partecipata arte collettiva; elementi che suggeriscono invece l'utilizzo di una maggiore attenzione alla sensazione, che a volte deve sfociare anche nel sensazionalismo (senza strafare, ovviamente: i parametri a disposizione sono numerosi e non per forza "americani").
Bisogna scendere a compromessi, insomma, senza vendere l'anima al diavolo o produrre tramette stiracchiate: vedi Roma, guarda caso di Cuaron, concepito apposta per lo streaming e decisamente avvolgente dall'inizio alla fine.
Insomma, film come questo sono ancora necessari, ma vanno impostati in altra maniera, altrimenti resta tutto fine a uno scatolone che fa finta di essere qualcosa che questo film non è riuscito a essere.
Da vedere in lingua originale.
26 novembre 2020
BREVE STORIA DI (QUASI) TUTTO di Bill Bryson
06 maggio 2020
due libri "tecnologici" editi da Adelphi
03 aprile 2020
Coronavirus, pipistrelli
Che poi io di grotte ne ho viste, ma l'idea di essere in piena foresta, circondati dal nulla, dall'altra parte del Pianeta... insomma, fa un certo effetto.
Aspetta che ti aspetta, sembrava non uscissero mai. Ma, invece, stavano uscendo in massa... solo che erano piccoli come una mano di un bimbo, o forse meno. Devo dire che fu suggestivo assistere a un tramonto velato dal passaggio di minuscoli schifezzine pelosette volanti.
Ora, i pipistrelli hanno due caratteristiche uniche, apparentemente lontane tra loro: sono gli unici mammiferi che sanno volare, hanno la pessima abitudine di ospitare virus con una certa facilità (tra il 5 e il 10 per cento della popolazione pipistrellosa; un'enormità rispetto a tutti gli altri possibili animali vi vengano in mente).
Ora, qui ci sono due scuole di pensiero che partono però dallo stesso punto: questo metabolismo pipistrellico libera una cicciottella quantità di radicali liberi (Pannella non c'entra nulla... o meglio: ricordiamo che voleva la Sanità privata; ma è un'altra storia).
Come ci insegnano negli spot soprattutto per femminucce, i radicali liberi fanno male alle cellule; e anche al DNA, aggiungono gli scienziati con gli occhiali a metà del naso.
Secondo alcuni di questi scienziati, questo superimpegno costante determina un consumo incredibile di energia. Ebbene, se si mettesse lì a consumare calore (la febbre, insomma) per buttar via buona parte dei virus che ospita, ecco che il pipistrello ci pensa due volte prima di riprendere a volare.
Quindi, è come se il sistema immunitario dei pipistrelli fosse ridotto al minimo. Allora sarebbero più vulnerabili? No! Visto che il virus ha bisogno di un vettore che si muova con una certa libertà, eccoli lì che non rompe le palle ai pipistrelli. Ma, ripeto, questo è un punto di vista.
L'altro punto di vista, invece, vede altri scienziati che dicono: è proprio l'ipermetabolismo a consentire ai pipistrelli di stare al riparo dai virus che ospitano. Un attore attivo di questo metabolismo, infatti, sono i mitocondri - dei cosetti responsabili della “respirazione” e quindi della produzione di energia.
Ma i mitocondri servono anche al sistema immunitario, e quelli dei pipistrelli so' grossi e tosti: 'sto mitocondrio pò esse' fero o pò esse' piuma, coi pipistrelli è acciaio. Quindi al maschio del futuro conviene avere il mitocondrio grosso, perché altrimenti col ca@@o che esce de casa.
Arriviamo all'uomo.
Conoscete il mito della caverna di Platone, giusto? 'Sti quattro scemi di spalle all'uscita che intravedono le ombre generate alla luce della Verità che sta alle loro spalle.
Bene, cosa abbiamo fatto noi? Anziché filosofeggiare come Platone e restare seduti con umiltà, siamo usciti dalla caverna (peraltro occupata dai pipistrelli) per cercare la Verità. Magari quella che più ci faceva comodo.
Abbiamo creduto fosse il Fuoco, e abbiamo quindi incaricato Prometeo di rubarlo agli dèi. Mal gliene incolse: fu prima arrestato e poi legato a un palo per farsi divorare il fegato da un corvo (tranquilli, Giove fu stronzetto: glielo faceva ricrescere di notte).
Abbiamo creduto fosse la Tecnologia. E allora abbiamo incaricato Steve Jobs di farla diventare necessaria e portatile. Mal gliene incolse: fu punito con un tumore al pancreas.
Abbiamo creduto fosse l'Ambiente. E allora abbiamo occupato ogni possibile spazio dell'Ecosfera, distruggendo ogni cosa, inquinando ogni anfratto della Terra, riducendo la Bellezza alla plastica banalità dei nostri selfie... e quindi costringendo anche i pipistrelli a sopravvivere in spazi sempre più ristretti.
E allora si sono incazzati loro al posto degli dèi, e ci hanno punito con una bella cacata infetta sopra un mercato rionale; e ci hanno ributtato dentro le grotte - le nostre case, insomma - con quel fuoco e quella tecnologia rubati agli dèi.
Siamo ritornati nella caverna, quindi, a fissare fissamente muri su cui proiettiamo le serie televisive... forse Platone meritava qualcosa di più.
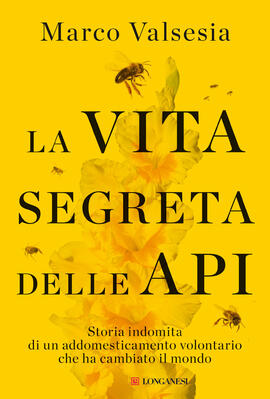
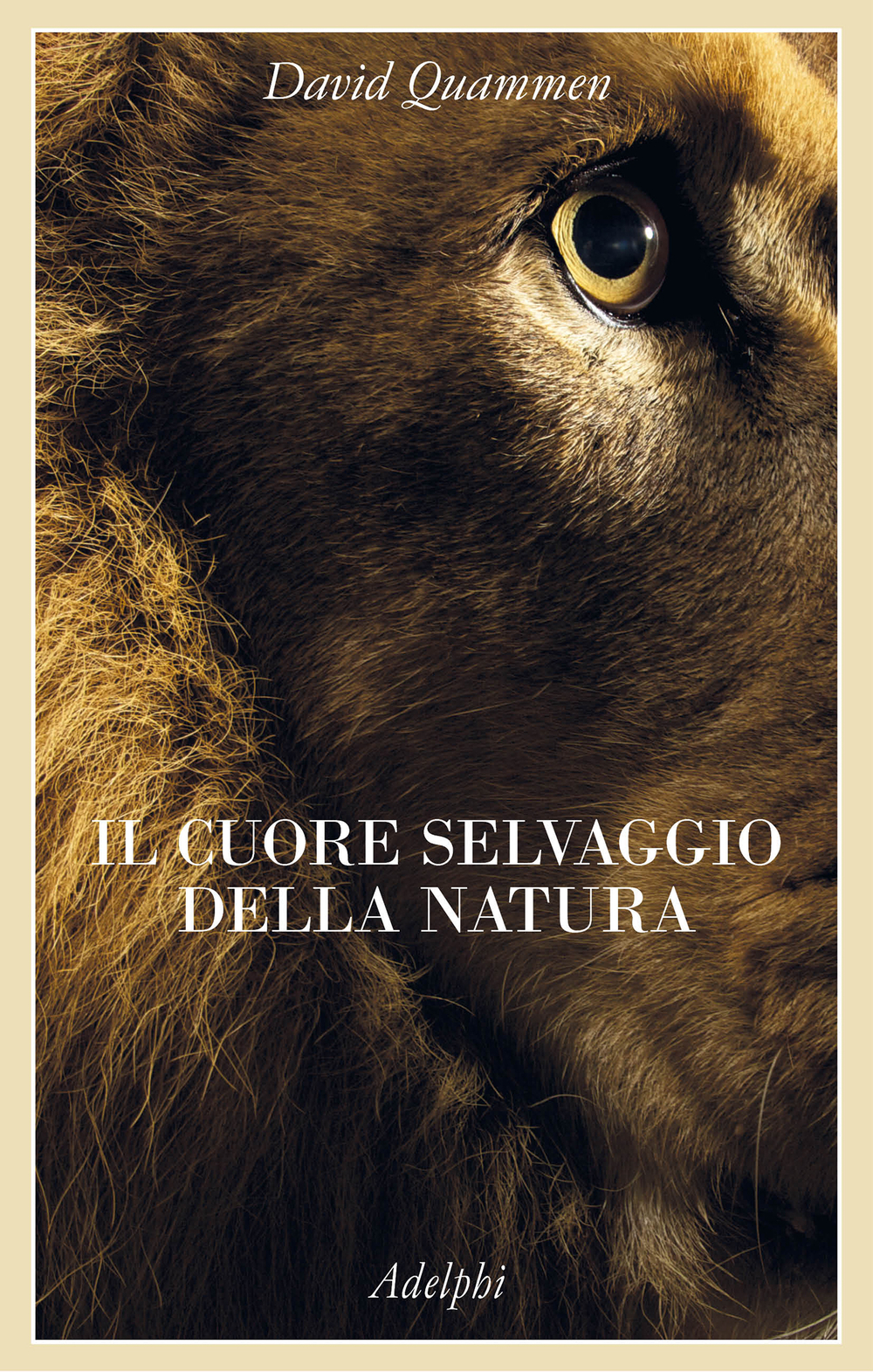
.jpg)