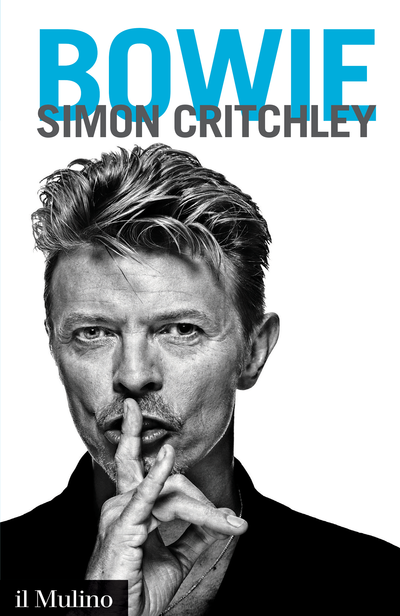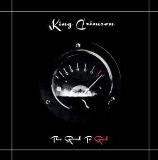Nella ormai indefinibile lunghissima storia dei King Crimson, In the Wake of Poseidon non gode di buona fama, nonostante alcuni momenti sublimi e la discontinua presenza dell'ormai ex Greg Lake. Alcuni critici frettolosi lo considerano una sorta di gemello povero del seminale In the Court of Crimson King, mentre io sono convinto che in esso si possano ascoltare momenti di sperimentazione e di modernissime intuizioni che destano poca attenzione solo a causa di alcune sonorità troppo datate.
Ad ogni modo, è un LP, CD, MP3 (fate un po' voi) che almeno una volta nella vita andrebbe ascoltato per intero, e magari consecutivamente. Anche e solo per un motivo: l'impatto con Cadence and Cascade, una perla di sublime bellezza che ancora oggi disarma per quella sua vellutata e rarefatta pastosità di note sottili e commoventi.
E la voce che vi accarezza l'anima è quella di Gordon Haskell, anche bassista del combo, nonché voce definitiva nel successivo Lizard (questo ancor più sperimentale, con una stridente coda vocale di Jon Anderson, la voce degli Yes).
Gordon Haskell discuteva spesso con il leader Robert Fripp, suo ex compagno di classe. D'aldronde chi è che non l'ha fatto? Il primo troppo vicino al folk e al jazz; il secondo, invece, incline alla quadratura dell'impossibile.
In linea generale, va detto che Fripp ha sempre preferito pescare (o inventare) le migliori voci tra i migliori bassisti, quasi fosse un requisito obbligato: Lake, Haskell, Burrell, Wetton, tutti bassismi distinguibili, presenti, alcuni rivoluzionari; Belew è stata un'eccezione, ma fino ad un certo punto, visto che ha un approccio armonico tipico del bassista in nuce.
In Lizard, Haskell dà prova di grande spessore, di acuta attenzione per le sfumature, anche di una certa volontà interpretativa, specie in Lady of the Dancing Water, come anche in Indoor Games. Però il tessuto musicale è così tetraedico, spigoloso, cerebrale, che ci si perde per strada tra le eccessive sperimentazioni; io le adoro, ma mi rendo conto che mettano a dura prova l'ascoltatore meno allenato.
Fatto sta che, appena finita l'intera registrazione, Haskell sbatte la porta in faccia a Fripp, perdendo il treno della fama e della gloria, riuscendo solo una volta - dopo faticosi tentativi troppo personali - a ritagliarsi una brevissima parte nella Storia della Musica nel 2002, con l'eccellente ballad How Wonderful You Are.
La prima volta che l'ascoltai, mi commossi e mi sentii anche in colpa: solo dopo capii chi era stato quel crooner ormai maturo, con le rughe piene di storie e la malinconia che scendeva dagli occhi.
Una voce cui abbiamo dato poco merito e che avrebbe potuto donarci più note senza tempo se solo avesse avuto la voglia di restare nel mondo dei normali.
Ma quando si è così dolci e insicuri, la vita non dà scampo, lasciandoti nel mondo della leggenda solo quando sei morto.
So long, Gordon, e grazie.