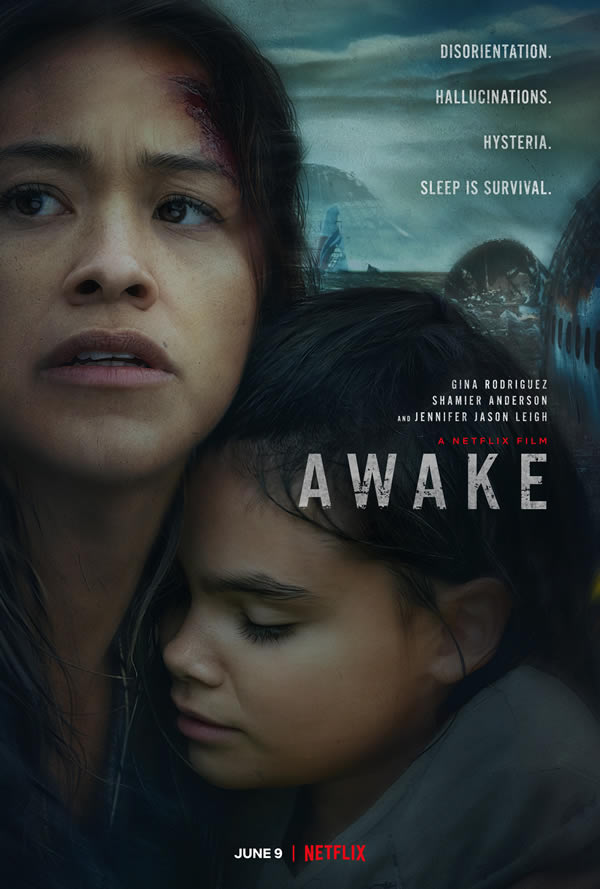In
Italia, di alcuni scrittori americani non conosciamo i libri, ma le
trasposizioni cinematografiche: uno di questi è Jack Finney; leggendo la sua scheda su Wikipedia, vi farete un’idea.Una delle sue opere più riuscite è Gli
invasati (1955), la cui prima trasposizione
cinematografica, L’invasione
degli ultracorpi (1956), fu affettuosamente descritta da noi italiani come “il film coi
baccelloni”. La regia è di Don Siegel, regista controcorrente
noto soprattutto per i suoi duri film con Clint Eastwood.
La trama ricalca quella del libro (tranne che per il finale): per invadere la
Terra, gli alieni mantengono un basso profilo, iniziando da un’isolata tipica
cittadina della provincia americana. E lo fanno tramite questi ciccionissimi
baccelloni, che contengono in nuce un abbozzo di copia del nostro corpo: come
ti addormenti, ZAC!, vieni sostituito da una copia identica a te, ma priva di
sentimenti e di empatia. La parte dolente è che chi è stato sostituito farà di
tutto per farvi sostituire, approfittando della nostra fisiologica necessità di
dover dormire; oltretutto, non è facile reagire violentemente contro chi
somiglia perfettamente a un nostro caro. Chiara denuncia contro il maccartismo,
vede un finalone buonista, poco amato dallo stesso regista.
La terza traduzione cinematografica (1993) è di Abel Ferrara, dimenticabile quanto
noiosetta. La quarta, invece (2007) vede tra i protagonisti la plastica
amimica di Nicole Kidman
e un distratto Daniel
Craig, appena rinfrancato dal suo primo 007; ed è poco sopra
l’asticella del trascurabile.
Non mi sono dimenticato della seconda trasposizione (1978, remake
dichiarato del primo film): Terrore
dallo Spazio profondo, un gioiello. A mio avviso, mantiene la
tensione dell’originale, con la sapiente aggiunta di una certa alienazione
tipica dei film anni ‘70, che rende la visione angosciante dall’inizio alla
fine. Al contrario del libro (dove i baccelloni scappano via, verso lo Spazio)
e degli altri film (dove comunque l’Umanità se la cava), qui il finale fa male,
malissimo. Ed è perfettamente rappresentato da Donald Sutherland, recentemente scomparso:
anche senza conoscere la trama nel dettaglio, guardate questo frammento.
E visto che ci piacciono i gradi di separazione (la cui traduzione cinematografica vede come protagonista sempre Sutherland)…
- lo scrittore Robert Heinlein aveva scritto qualcosa di simile agli Ultracorpi qualche anno
prima: Terrore dalla Sesta
Luna (1951). Ora, è vero che il timore che qualcuno
controlli le nostre menti e le renda remissive è frequente nella narrazione
moderna, ma è curiosa la quasi contemporaneità dei due testi, come anche la
“novità aliena”
- la coincidenza incredibile è che Sutherland reciterà anche nella traduzione
cinematografica del libro di Heinlein
(1994)
- a questo, aggiungiamo che proprio il testo di Heinlein ispirerà il 29esimo
episodio della prima stagione di Star
Trek TOS (1967), in cui recita anche Leonard “Spock”
Nimoy. Indovinate? Nimoy apparirà accanto a Sutherland in Terrore dallo Spazio profondo
- il protagonista del romanzo di Heinlein beve solo Martini “agitato, non mescolato”… chi vi ricorda? Già, Ian Fleming: ne farà tesoro, infatti, quando dovrà caratterizzare il suo James Bond (1953)
- - -
Quando uscì sulla mia rassegna settimanale l’aneddoto che chiude questo post, mia moglie mi propose di andare a visitare Bomarzo.
Durante il tragitto, dal suo Spotify uscì una canzone che gli appassionati della serie Stranger Things (2016) conoscono molto bene: “Running Up That Hill” (1985), dolce capolavoro di Kate Bush.
Se la serie ha consentito alla mia generazione di incontrare quelle attuali, quelle attuali hanno potuto conoscere una delle voci più incantevoli della nostra adolescenza, scoperta e aiutata insospettabilmente da David Gilmour, chitarra e voce dei Pink Floyd.
Di Kate Bush ricordiamo tanti piccoli gioielli, non ultimo “Cloudbusting” (uscito sempre nel 1985), il racconto commosso ed empatico di un inventore incompreso che avrebbe escogitato un marchingegno per far piovere là dov’è necessario, ma cui nessuno dà credito se non il giovanissimo figlio.
E chi è il protagonista del video ufficiale? Sempre lui, Donald Sutherland, all’inizio riluttante, ma poi partecipe ed entusiasta
- - -
E veniamo a Bomarzo.
Un'altra curiosità che mi è venuta in mente pensando a Donald Sutherland, riguarda anche un luogo magico dell’infanzia, almeno per i romani della mia generazione.
La prendo alla lontana. Se vi chiedessi chi sono Anthony M. Dawson, Bob Robertson, Hank Milestone, George Eastman e Joe D'Amato, forse impieghereste qualche minuto per darmi una risposta. Ma se vi dicessi che sono i nomi d’arte di Antonio Margheriti, Sergio Leone, Umberto Lenzi, Luigi Montefiori e Aristide Massaccesi?
Era una prassi quasi scontata che registi italiani alle prime armi - o di film di basso costo - firmassero le proprie regie con nomi stranieri, per dare quel non so che alle loro opere. Eravamo ai confini dell’impero: per quanto il nostro cinema fosse migliore di quello USA (fino agli anni ‘80; poi, da “Nuovo Cinema Paradiso” è iniziato il declino), si sentiva il bisogno di darsi un tono.
Raramente, è capitato il contrario: con l’americano Warren Kiefer, per esempio, che usò il nome Lorenzo Sabatini per le sue regie in Italia. Il film per cui lo conoscete inconsapevolmente è “Il castello dei vivi morti” (1964), perché girato in b/n soprattutto tra i mostri di Bomarzo. È un inquietante gotico all’italiana, sicuramente datato, che vede al suo esordio proprio il nostro Donald Sutherland, addirittura interpretando tre personaggi diversi (tra cui una vecchina cattivella).
Da lì, l’attore canadese prese il volo, diventando l’eccellente e poliedrico interprete di numerosi classici. Ma non dimenticherà quel suo esordio, tanto da chiamare uno dei suoi figli con il cognome del regista, Kiefer: Kiefer Sutherland



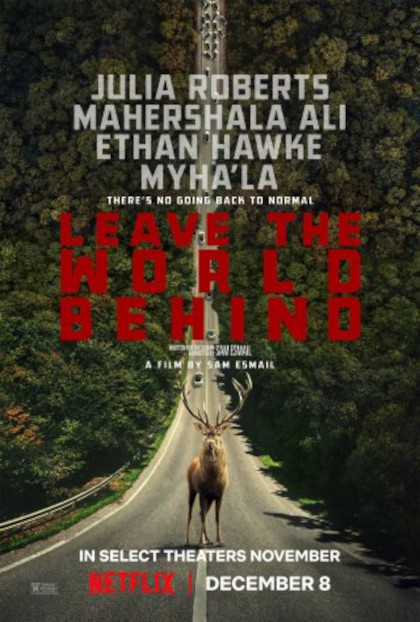







.png)