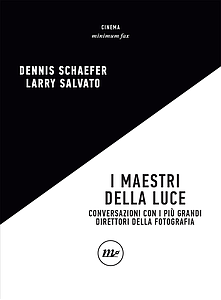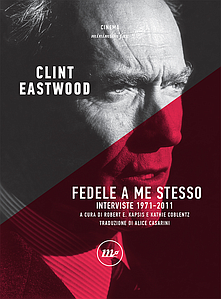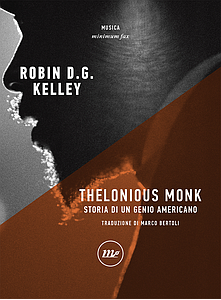Un buon compendio, che si legge tutto d'un fiato e che lascia pochissimo spazio al dissimulato egocentrismo degli intervistatori. Viene fuori un ritratto di un grandissimo artista che ha saputo segnare la Storia del Cinema e insegnare come si fa Cinema.
Le interviste raccontano solo l'Eastwood regista, e si fermano fino a J. Edgar. Si dipanano dietro direttrici intuibili e sotto molti aspetti sembrano "pilotate" dolcemente anche da Eastwood, che sa come rispondere e come accompagnare quindi gli intervistatori verso domande interessanti e intelligenti.
Tra gli elementi che arrivano subito al lettore, spicca come venga intesa da Eastwood la praticità: in realtà, è uno strumento per arrivare immediatamente all'autenticità, senza tanti fronzoli; più prove fai, infatti, e più si perderà la spontaneità della recitazione e dell'idea filmica. Eccoli lì che il mantenersi sotto i budget previsti sembra quasi una cifra stilistica; paradossale, insomma, che il punto d'incontro tra i produttori ed Eastwood sia un elemento che sembra una cosa ma che in realtà è ben altro.
Un altro pregio di Eastwood è che non pretende di sapere cosa penserà lo spettatore. E neanche pretende che lo spettatore capisca quello che per lui dev'essere capito; una (doppia) dote rarissima, che solo persone umili ma determinate riescono a mantenere nel giusto equilibrio.
Infine, la serenità: notoriamente Eastwood mette a proprio agio attori e tecnici, creando un ambiente favorevole al buon lavoro, a seguire e arricchire il progetto, a stimolare idee e intuizioni dei professionisti coinvolti. Tant'è che in alcune circostanze, Eastwood per primo ha cambiato idea in corsa, stimolato proprio da quello stesso ambiente così accogliente e proattivo.
Fin qui abbiamo parlato di carattere. Quello che reputo essere il vero talento di Eastwood è saper scegliere il film da girare e come girarlo, seguendo solo i propri gusti, senza compromessi con il voler compiacere ad ogni costo o la ricerca del successo. Il che non significa essere "contro" in maniera gratuita e stucchevole, ma semplicemente attenersi alla propria personalità.
Sono interviste ricche, che in rari casi vedono ribadire alcuni pensieri in contesti diversi: in realtà, è un pregio, perché consente al lettore di mantenere ben saldo nella memoria quel pensiero del regista, per sperimentarlo in ambiti differenti.
Conosco la filmografia e le interpretazioni di Eastwood dagli inizi, quando cioè qui in Italia andava odiato perché "fascista". Ero molto giovane e mi colpiva sia la virulenza di quelle posizioni che il pregiudizio intellettuale che le alimentava. Mai come in questo caso, però, la pochezza della critica militante fece un favore alla persona che insultava, visto che più aggrediva Eastwood e più si gonfiavano le fila dei suoi estimatori. Anzi, invecchiando, Eastwood si è preso una rivincita, visto che anche quei contestatori si sono trasformati in estimatori.