Ottavo pannello della mirabile opera in fieri di Roberto Calasso, questo Cacciatore Celeste ha dei momenti di raro romanticismo, altri di una profondità intellettuale che inebria, altri ancora in cui l'autore indugia su alcuni momenti delle sue opere precedenti.
Libro straordinario e pieno di vita propria, in cui ogni tanto, però, sembrano entrare in conflitto il tema trattato e lo stile tipicamente "calassiano".
L'autore, infatti, procede per campate (come direbbe Rilke), ponendo sub-paragrafi dentro capitoli decisamente sistemici, costringendo il lettore a un gioco vorticoso di avanti/indietro tra una pagina e l'altra, tra un paragrafo e l'altro, tra un capitolo e l'altro. Non è un male, visto che poi è - appunto - lo stile cui ci ha abituati. Ma in questo contesto si corre il rischio di perdere l'insieme.
L'autore, infatti, procede per campate (come direbbe Rilke), ponendo sub-paragrafi dentro capitoli decisamente sistemici, costringendo il lettore a un gioco vorticoso di avanti/indietro tra una pagina e l'altra, tra un paragrafo e l'altro, tra un capitolo e l'altro. Non è un male, visto che poi è - appunto - lo stile cui ci ha abituati. Ma in questo contesto si corre il rischio di perdere l'insieme.
E in un certo senso, è Calasso stesso ad ammetterlo quando dice: "Si scrive un libro quando si precisato qualcosa che si deve scoprire. Non si sa cos'è né dov'è, ma si sa che si deve trovarlo. Allora comincia la caccia. Si comincia a scrivere". ≪Comincia la caccia≫, appunto, sia per chi scrive che per chi legge; e come suggerisce anche l'idea filmica del cacciatore che abbiamo un po' tutti, molte volte ci aggiriamo tra frasi e concetti rovistando troppo nello stesso punto.
Sul perché si soffermi sull'idea del cacciatore, Calasso ne aveva già parlato in alcune delle sue opere precedenti - e che riassume così: "La caccia nasce come atto inevitabile, finisce come atto gratuito [...] Non si sa che cosa avviene fra il cacciatore e la preda quando si affrontano. È certo, però, che prima della caccia, il cacciatore compie gesti di devozione. E, dopo la caccia, sente l'esigenza di scaricarsi una colpa".
Il cacciatore come esempio di umanizzazione, di Homo (come dirà spesso in questo libro), come lenta e inesorabile negazione del suo rapporto con la Natura: "Quando si compì il distacco da qualcosa che si sarebbe chiamato animale da qualcosa che si sarebbe chiamato uomo, nessuno pensò che la sapienza - la vecchia e la nuova sapienza - potesse trovarsi se non in qualcuno che partecipasse alle due forme di vita".
Sul perché si soffermi sull'idea del cacciatore, Calasso ne aveva già parlato in alcune delle sue opere precedenti - e che riassume così: "La caccia nasce come atto inevitabile, finisce come atto gratuito [...] Non si sa che cosa avviene fra il cacciatore e la preda quando si affrontano. È certo, però, che prima della caccia, il cacciatore compie gesti di devozione. E, dopo la caccia, sente l'esigenza di scaricarsi una colpa".
Il cacciatore come esempio di umanizzazione, di Homo (come dirà spesso in questo libro), come lenta e inesorabile negazione del suo rapporto con la Natura: "Quando si compì il distacco da qualcosa che si sarebbe chiamato animale da qualcosa che si sarebbe chiamato uomo, nessuno pensò che la sapienza - la vecchia e la nuova sapienza - potesse trovarsi se non in qualcuno che partecipasse alle due forme di vita".
Chi presidia, quindi, la relazione tra uomo e Natura? Chi riesce a mantenere il giusto equilibrio tra le due parti? Qui interviene una lettura interessante di una figura anch'essa vittima di una certa banalizzazione filmica: lo sciamano. "I mondi sono tre e gli uomini normalmente stanno in quello di mezzo. Lo sciamano, invece, in tutti e tre [...] Cacciatori e sciamani sono gli esseri più affini. Spesso parlano lo stesso linguaggio segreto, che poi è quello degli animali [...] Essere sciamani era un'altra vita che presupponeva l'offerta e la scomposizione del proprio corpo, così simile a quella che subivano gli animali sacrificati".
Ora, c'è un elemento che dobbiamo tenere a mente: l'oralità. Il ciclo di ogni evento si mantiene integro solo attraverso l'eredità orale: "Gli uomini diventano metafisici durante la caccia. L'agricoltura avrebbe aggiunto al pensiero soltanto un dato essenziale: il ritmo, l'alternarsi tra fiorire e appassire". Ma quando si arriva alla storicizzazione, questo equilibrio tra Homo e Natura viene meno: "Finché non venne inventata la scrittura, era impossibile fissare in una forma di storia ciò che accadeva". Chiaramente, anche i luoghi segnano la sconfitta di questa ciclicità, perché ogni forma di ritualizzazione (lo strumento attraverso cui sopravvive un'idea di ciclo) perde la sua forza naturale: "La città è il luogo ideale dove l'animale guida viene abbattuto".
Ora, c'è un elemento che dobbiamo tenere a mente: l'oralità. Il ciclo di ogni evento si mantiene integro solo attraverso l'eredità orale: "Gli uomini diventano metafisici durante la caccia. L'agricoltura avrebbe aggiunto al pensiero soltanto un dato essenziale: il ritmo, l'alternarsi tra fiorire e appassire". Ma quando si arriva alla storicizzazione, questo equilibrio tra Homo e Natura viene meno: "Finché non venne inventata la scrittura, era impossibile fissare in una forma di storia ciò che accadeva". Chiaramente, anche i luoghi segnano la sconfitta di questa ciclicità, perché ogni forma di ritualizzazione (lo strumento attraverso cui sopravvive un'idea di ciclo) perde la sua forza naturale: "La città è il luogo ideale dove l'animale guida viene abbattuto".
Escluso lo sciamano, che comunque è Homo, la prima vera cultura europea istituzionalizzò l'idea del cacciatore attraverso una delle dee più interessanti del variegato panorama mitologico greco: Artemide, che "non si curò mai della caccia come opera civilizzatrice, che mirava a sterminare belve e mostri, bonificando la natura strapotente. Anzi, la avversava. Per la dea la caccia era un gioco che ricominciava ogni volta, monotono e invincibile".
In un solo caso, Artemide uccide senza volerlo, ma per colpa di un brutto tiro di Apollo: la vittima è l'amato Orione. Sarà la dea stessa a consegnare poi Orione al cielo, insieme al suo fido Sirio (il ≪cane maggiore≫), perché per gli dèi greci "Quando qualcuno non può più essere trasformato, ma va salvato, diventa astro".
Artemide è nodale perché condiziona anche la storia d'amore comunque travagliata tra Procri e Cefalo. "Figlia del re di Atene, innamorata di un giovane che veniva da un porto minore dell'Attica, Procri aveva vissuto in un periodo di guerre, quando per la prima volta gli Ateniesi si erano dati il nome di Ateniesi. Ciò che si tesseva in lei, sin dall'infanzia, era una ragnatela di emozioni: un giorno si sarebbero chiamati sentimenti. Ebbe a che fare con sovrani e con dee, ma la sua vicenda, da un capo all'altro, fu totalmente privata [...] Polignoto dipinse Procri offesa dalla gelosia e recriminante anche negli Inferi. L'arte di quei greci non compendiava soltanto il passato, ma già sbrogliava, filo per filo, la matassa di ciò che si sarebbe chiamato letteratura".
Inevitabilmente, con questo passaggio nel mondo greco, Calasso è quasi costretto ad affrontare anche la breve età degli eroi, cacciatori sotto altre spoglie, entrando dentro storie che hanno fatto parte anche del nostro immaginario collettivo, tra cui Giasone e il Vello d'Oro. Eroi cui va inserita in qualche modo, quasi incastrata, anche la figura di Odisseo, di quel suo essere ucciso dal figlio che aveva concepito con Circe; ucciso proprio all'indomani del suo ritorno ad Itaca, dove aveva trovato ad aspettarlo Penelope e Telemaco. E nonostante questo omicidio, sarà proprio Telegono a recarsi in Italia con il fratellastro e Circe.
Ecco, è su questi strappi narrativi che si rischia di perdere per strada il tema principale del saggio. Per fortuna, ci viene in soccorso il capitolo successivo ≪Sapienti e predatori≫: "La caccia è il luogo dove si svolge lo sdoppiamento primordiale, la divaricazione da cui tutte le altre discendono. La preda diventa cacciatore nel momento in cui uno sguardo si posa su un essere distinto da sé. In quello sguardo sorge il cacciatore, che fino a quel momento era stato un animale in mezzo agli altri. Era l'animale. Ora, diventando lo sguardo che osserva l'animale, era tenuto anche a ucciderlo".
All'inizio di questa recensione, e anche quindi del saggio, abbiamo incontrato la parola ≪colpa≫, che è quasi strumento di espiazione per l'essere diventati Homo: "Ci furono due peccati capitali: la separazione e l'imitazione. La separazione avvenne quando Homo decise di opporsi al continuum zoologico, prendendo alcuni animali al suo servizio e considerando gli altri come materiale potenzialmente utile per i suoi fini. L'imitazione quando Homo si avvicinò, nel suo comportamento, ai predatori. Una volta compiuto il passaggio alla predazione, Homo non sapeva come trattare quella nuova parte della sua natura. Scelse di circoscriverla nel suo significato letterale e di espanderla indefinitamente come metafora Inventò la caccia come attività non indispensabile, gratuita. Fu la prima arte per l'arte".
E dopo questa chiosa disarmante e anche "logica", Calasso aggiunge un corollario che diventa la pietra angolare della citazione precedente: "Nel regno animale, gli esseri continuavano a vivere come avevano sempre vissuto. Ripetevano immancabilmente gli stessi gesti. Quando Homo si trasformò in predatore, inferse una lesione in questo ordine delle cose. Da allora ogni uccisione fu anche un segnale che ravvivava il ricordo di quel passaggio. E intorno a quel ricordo si elaboravano altri gesti, ripetuti con regolarità. Il rito permetteva di non discostarsi troppo dagli altri viventi".
All'inizio di questa recensione, e anche quindi del saggio, abbiamo incontrato la parola ≪colpa≫, che è quasi strumento di espiazione per l'essere diventati Homo: "Ci furono due peccati capitali: la separazione e l'imitazione. La separazione avvenne quando Homo decise di opporsi al continuum zoologico, prendendo alcuni animali al suo servizio e considerando gli altri come materiale potenzialmente utile per i suoi fini. L'imitazione quando Homo si avvicinò, nel suo comportamento, ai predatori. Una volta compiuto il passaggio alla predazione, Homo non sapeva come trattare quella nuova parte della sua natura. Scelse di circoscriverla nel suo significato letterale e di espanderla indefinitamente come metafora Inventò la caccia come attività non indispensabile, gratuita. Fu la prima arte per l'arte".
E dopo questa chiosa disarmante e anche "logica", Calasso aggiunge un corollario che diventa la pietra angolare della citazione precedente: "Nel regno animale, gli esseri continuavano a vivere come avevano sempre vissuto. Ripetevano immancabilmente gli stessi gesti. Quando Homo si trasformò in predatore, inferse una lesione in questo ordine delle cose. Da allora ogni uccisione fu anche un segnale che ravvivava il ricordo di quel passaggio. E intorno a quel ricordo si elaboravano altri gesti, ripetuti con regolarità. Il rito permetteva di non discostarsi troppo dagli altri viventi".
Interessante, quindi, stabilire il peso psicologico dell'essere diventato cacciatore: "L'uomo non è un predatore nato, ma un predatore acquisito [...] I predatori sono indifferenti agli animali che non uccidono. Non così Homo, che intendeva trarre profitto da tutti gli animali [...] Homo non era un carnivoro per costituzione, il passaggio alla dieta carnea fu un evento nella sua storia. Anzi, il primo evento precisabile".
Che l'Homo non sia all'altezza del ruolo che sta acquisendo, viene spiegato in questo modo: "Homo apprende più difficilmente e più lentamente rispetto agli altri animali [...] Se non disponesse di una radicale indeterminazione, Homo non potrebbe sviluppare le sue enormi capacità di imitazione. Il ritardo dello sviluppo accresce la potenzialità di sviluppi".
Ma cosa resta della Natura? "Da Descartes in poi, i grandi filosofi che si incontrano nei manuali hanno dato una prova meschina nel trattare degli animali. Più che un modo per pensarli, la filosofia era una strategia per difendersi dal doverli pensare".
Ma cosa resta della Natura? "Da Descartes in poi, i grandi filosofi che si incontrano nei manuali hanno dato una prova meschina nel trattare degli animali. Più che un modo per pensarli, la filosofia era una strategia per difendersi dal doverli pensare".
Il saggio procede a grandi passi verso un momento a metà tra il mito e la filosofia. Per farlo, bisogna passare per Eracle, cacciatore ma anche figlio di un dio, eterno ma mortale, invincibile ma non indistruttibile: "Spesso gli eroi erano innanzitutto cacciatori. Al contrario di loro, per diventare eroe Eracle dovette rinnegare in sé il cacciatore [...] Anche se gli eroi erano figli o discendenti di Zeus e di una mortale, e questo li avvicinava nella vita agli dèi, al pari degli uomini incontravano la morte". Il secondo concepimento di Eracle è struggente e doloroso al tempo stesso. Mentre Zeus vi assiste, si rende conto che quel compromesso con l'Homo lo porterà dentro al mito, e quindi alla fine del suo ciclo.
L'altro baluardo della resistenza alla modernità è la metamorfosi. Di conseguenza, Calasso dedica un intero capitolo a Ovidio: "Le Metamorfosi sono storie dentro storie, incastonate, autosufficienti. Nella loro immediatezza, tutte potrebbero fare a meno delle altre. Ma ciascuna è illuminata dalla sua cornice e solo dalla cornice trae un significato ulteriore". Se non è lo sciamano, se non sono gli dèi, forse la lettura di Ovidio potrebbe salvarci dal nostro essere diventati Homo? Evidentemente no, come si evince in questo passaggio: "Durante il regno della Metamorfosi si diventa ciò che si era. Più tardi, un velo di opacità si era steso progressivamente sul mondo. Era venuto a cadere ogni rapporto tra ciò che si era e come si appariva".
Uno dei fari intellettuali cui Calasso sembra identificarsi, è la figura di Plotino, cui viene dedicato un capitolo che apparentemente si discosta dal tema del saggio. La sua fuga del solo verso il solo nasce dalla sua conoscenza diretta di quelle culture che abbiamo incontrato noi "calassiani" leggendo sia Ka che L'ardore: la non-conoscenza è superiore alla conoscenza; l'Uno è un non-essere, non è sostanza, non è vita. Il pensiero deve andare oltre se stesso, abolendosi, annientandosi, rifiutandosi.
L'altro baluardo della resistenza alla modernità è la metamorfosi. Di conseguenza, Calasso dedica un intero capitolo a Ovidio: "Le Metamorfosi sono storie dentro storie, incastonate, autosufficienti. Nella loro immediatezza, tutte potrebbero fare a meno delle altre. Ma ciascuna è illuminata dalla sua cornice e solo dalla cornice trae un significato ulteriore". Se non è lo sciamano, se non sono gli dèi, forse la lettura di Ovidio potrebbe salvarci dal nostro essere diventati Homo? Evidentemente no, come si evince in questo passaggio: "Durante il regno della Metamorfosi si diventa ciò che si era. Più tardi, un velo di opacità si era steso progressivamente sul mondo. Era venuto a cadere ogni rapporto tra ciò che si era e come si appariva".
Uno dei fari intellettuali cui Calasso sembra identificarsi, è la figura di Plotino, cui viene dedicato un capitolo che apparentemente si discosta dal tema del saggio. La sua fuga del solo verso il solo nasce dalla sua conoscenza diretta di quelle culture che abbiamo incontrato noi "calassiani" leggendo sia Ka che L'ardore: la non-conoscenza è superiore alla conoscenza; l'Uno è un non-essere, non è sostanza, non è vita. Il pensiero deve andare oltre se stesso, abolendosi, annientandosi, rifiutandosi.
Il capitolo successivo affronta una cultura cui sia i greci che Plotino devono molto: gli egizi. Calasso li ricorda per quel loro incredibile rapporto che avevano con gli animali, vera e propria origine dei misteri greci. Erano "barbari", ma non nella accezione che crede la vulgata comune: "I barbari erano civiltà più antiche della Grecia, che avevano raggiunto una sapienza altissima e immobile". E qual è il nesso con il saggio che stiamo leggendo? "Mentre gli egizi cercarono di raggiungere la massima animalizzazione dell'uomo, la vita dei greci ruotava attorno a un cardine: il riconoscimento degli dèi".
E quindi torniamo allo schema originario del saggio: "All'inizio: non c'era caccia senza il divino; non c'era il divino senza caccia. Poi venne un momento in cui la caccia non ebbe più nulla a che fare con il divino e ciò che veniva chiamato divino non aveva pressoché nulla a che fare con il divino".
Resta un'ultima chance, quindi, quando Calasso riconduce ai Misteri - mutuati proprio dagli egizi - l'ultima possibilità dell'Homo di ricongiungersi al ciclo, alla Natura: "I Misteri non sono una cosa che si possiede, come un pensiero; non sono qualcosa che si applica, come una formula. Sono un luogo che offre qualcosa di ulteriore ogni volta che vi si torna. Ma per tornarvi occorre allontanarsene, rientrare nella vita comune - e poi lasciarla di nuovo".
- La rovina di Kasch (1983)
- Le nozze di Cadmo e Armonia (1988)
- Ka (1996)
- K. (2002)
- Il rosa Tiepolo (2006)
- La folie Baudelaire (2008)
- L'ardore (2010)
- Il Cacciatore Celeste (2016)
- L’innominabile attuale (2017)
- Il libro di tutti i libri (2019)
- La Tavoletta dei Destini (2020)
- Opera senza nome (2024 - postumo)
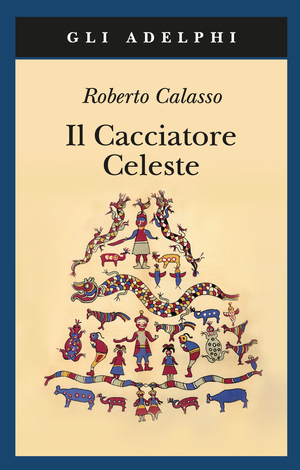
Nessun commento:
Posta un commento